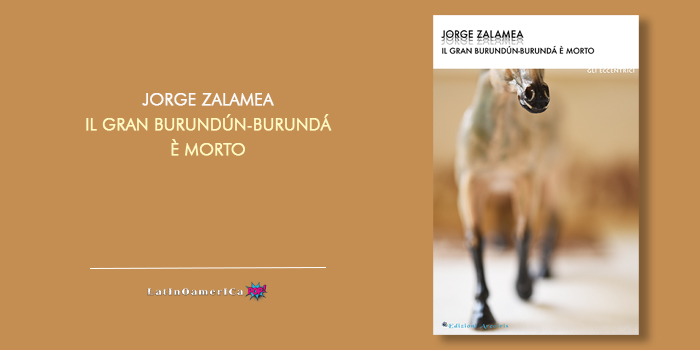“Il genio artistico è il termometro della cultura dei popoli”.
“Che ne sarebbe di noi senza di lui, l’unico in grado di alleviare il dolore, oasi di pace per le anime?”.
 È Débora dell’ecuadoriano Pablo Palacio (Loja 25.01.1906 – Guayaquil 7.01.1947), nell’ottima traduzione di Alice Piccone, il cinquantatreesimo volume della collana Gli eccentrici, curata dalla casa editrice salernitana Edizioni Arcoiris, che ancora una volta ci regala la possibilità di confrontarci con una voce che, con le sue opere, è stata in grado di trascendere i confini e le etichette imposte dalla letteratura.
È Débora dell’ecuadoriano Pablo Palacio (Loja 25.01.1906 – Guayaquil 7.01.1947), nell’ottima traduzione di Alice Piccone, il cinquantatreesimo volume della collana Gli eccentrici, curata dalla casa editrice salernitana Edizioni Arcoiris, che ancora una volta ci regala la possibilità di confrontarci con una voce che, con le sue opere, è stata in grado di trascendere i confini e le etichette imposte dalla letteratura.
Gli individui rappresentati da Palacio nei suoi testi e che fanno da contorno alla storia principale sono individui penzolanti; si muovono tra le strade quasi per inerzia e si rapportano con i loro simili attraverso formule impostate: è questa l’immagine che si ha di loro, quando li si incontra tra le prime pagine di Débora, romanzo pubblicato per la prima volta nel 1927. L’autore ecuadoriano cerca di fotografarne quell’animo nascosto dietro le loro vesti e i loro ruoli, intrappolato nella complessità della vita e che «profondamente incompreso, trae stimolo da banali cambiamenti nella quotidianità», come succede al “nostro” Tenente, che camminando trova una banconota, metafora di tutti quei progetti che avrebbe potuto realizzare con un milione di sucres a disposizione, ma che sono sfumati a causa degli artigli della vita affondati in un petto che hanno schiacciato, “delineando così la formula del lasciar stare”. E questo “lasciar stare” domina la narrazione, che vede il peregrinare di questo personaggio in una moltitudine di strade, senza uno scopo ben preciso.
La realtà è che non è neanche questo Tenente il vero protagonista, ma colui che lo ha creato, un autore che dà vita a una narrazione frammentata, che altro non è che il montaggio di episodi dall’inizio poco chiari e che effettivamente non trovano una conclusione, se non nella consapevolezza di chi scrive che non è quella la piega che vuole che la storia prenda; dunque si concludono dissolvendosi, per lasciare spazio ad altri episodi, altre strade e altre mosse, che servano in qualche modo a dare un contorno a un personaggio che definizione non ha, prigioniero delle sue mancanze.
E il romanzo? Si conclude com’è iniziato, con l’immagine di colei che forse avrebbe dato un senso all’intero percorso, Débora, ancora lontana, inafferrabile, irraggiungibile, e con un autore che ormai arreso abbandona il suo protagonista, figurazione di quel “vuoto della volgarità”, affinché possa tormentare altri animi, succubi della realtà e di quel disordine che potrebbe trovare soluzione solamente nell’artificio, forse la chiave “per dare al Tenente ciò che non ha avuto. […] Ma non è qui che troveremo questa storia: bisognerà cercarla nell’indice di qualche romanzo rosa”.
Come iniziare a descrivere quello che avviene tra queste pagine, se non con le parole dell’autore che scrive: “Il romanzo si disfa nella pigrizia, e allora vorrei frustarlo affinché salti, gridi, sgroppi, riempia di brio i corpi flaccidi; in tal modo, però, farei un’operazione di letterarizzazione”.
Sulla scia di queste parole, il vero nucleo di questo libro è nella riflessione metaletteraria compiuta dallo scrittore, che rende il lettore partecipe del processo relativo alla costruzione del romanzo, un processo che non va a buon fine, anzi diventa testimone di un decostruirsi di quelle tessere e sovrastrutture, “fino a sembrare una tabula rasa su cui l’emozione non ha scritto alcunché”.
In queste pagine che sembrano un castello di carta instabile e destinato a crollare, però, c’è una ratio ben definita e per comprenderla è necessario risalire al contesto socio-politico e culturale in cui Palacio scrive. Si parla di un’epoca, anzi della fase di un’epoca fatta di grandi cambiamenti – per dirla con le parole dell’autore, “stiamo vivendo la transizione del mondo” – che trovano un minimo comun denominatore nel progresso che investe la collettività, non senza disparità e/o contraddizioni; la letteratura che si propone di descrivere queste dinamiche è una letteratura di stampo sociale, adagiata sugli schemi del romanzo realista, che al momento di ritrarre la gente si mostra fin troppo approssimativa, limitandosi dunque a narrare una semplice «parvenza della realtà» che nega di fatto a tanti individui la propria rappresentazione e crea personaggi imprigionati nelle proprie apparenze.
È a questa tendenza che, con Débora, Palacio si contrappone, creando il Tenente, l’immagine di “quei manichini dappoco fatti di carta e lettere stampate, senza idee, che nella vita si muovono come ombre”.
L’autore ecuadoriano lo osserva sotto la lente della sua esasperante ironia, invitando anche il suo lettore a “riflettere sull’instabilità mentale” di questo protagonista, un imitatore sociale, di cui sceglie di dipingerne psicosi e fissazioni che dagli scrittori che si muovono solo attraverso delle “supposizioni” mai verrebbero contemplate, finendo per diventare creatori di fantocci impersonali, oggetto delle opere di questo giovane romanziere che, scavando nella loro interiorità, li ha usati per mostrare ai suoi lettori la sostanziale differenza che vi è tra ciò che è “reale”, fatto di quelle realtà voluminose e le loro maschere, e ciò che è “vero”, fatto delle “piccole realtà che accumulandosi costituiscono la vita”. E la verità è sempre stata alla base della ricerca di Pablo Palacio, arrivato da Loja, “dall’ultimo angolo del mondo”, che a quel tempo ancora non sapeva che la sua poetica sovversiva, che si fa beffa di qualsiasi “ideale letterario irraggiungibile”, avrebbe aperto la strada a una lunga tradizione che di quella deriva realista che la letteratura stava assumendo ne avrebbe finalmente rivelato l’inganno.
Claudia Putzu