Ci si avvia verso la fine dell’anno e, come di consueto, è tempo di classifiche. Eppure tale concetto è un qualcosa che non mi appartiene, e questo elenco di titoli non è disposto – in alcun modo – in ordine di gradimento, ma è il mio modo per salutare l’anno uscente, che di letture è stato povero, e accogliere il nuovo con quei libri che mi hanno accompagnata, alcuni a cui ho lavorato, altri che ho presentato, infine quelli che sono stati oggetto del mio (e della mia compagna di viaggio) gruppo di lettura e hanno generato discussioni profonde e interessanti. Con ciò mi avvio a quello che è il mio unico proposito e speranza per il 2024: parlare di libri, che si parli di libri, con gli amici, con i lettori che si incontrano lungo il cammino e con quelle persone che si ritrovano a passare nel luogo di una presentazione per caso e si avvicinano, poiché sono i libri che – come scrive Magallanes nel suo El Palomar – ritagliano il mio posto su questa terra.
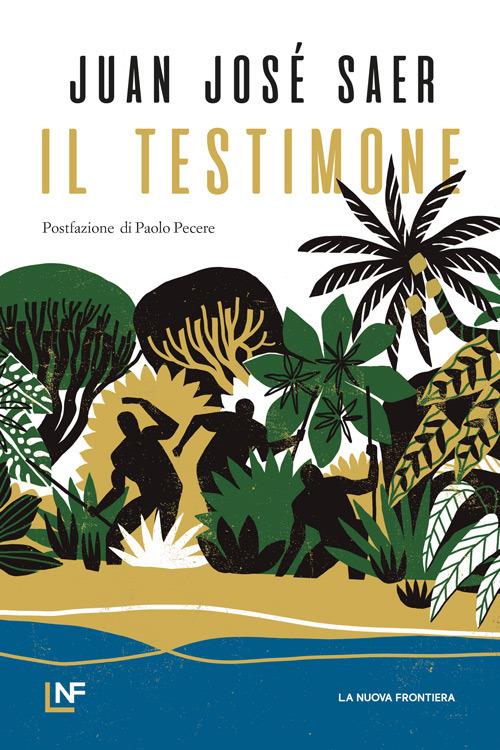 Il Testimone, Juan José Saer (La Nuova Frontiera, trad. Luisa Pranzetti). Un’opera che si colloca al di là delle frontiere, nata dalla penna di quello che è uno di più grandi scrittori della letteratura in qualsiasi lingua: così ne parla Ricardo Piglia. Con il romanzo in questione, l’autore argentino tesse le trame della vita di un mozzo quindicenne, orfano e solo al mondo, che intraprende il viaggio verso la terra (presunta) vergine delle ancora chiamate “Indie”, per finire rapito insieme ai suoi compagni da una tribù indigena di cannibali; a differenza loro, lui non finirà sulla graticola. Con descrizioni minuziose, raccontate con un linguaggio preciso, che attinge a un lessico e a strutture che rendono la lettura avvolgente, l’Io narrante anziano ripercorre quegli anni di osservazione e i sentieri che da lì si sono aperti durante il suo vagare in un deserto secco, indefinito e calcinato, per parlare a chi legge dell’esperienza umana, delle impronte dei suoi passi e delle sue cadute, percorso al quale spetta un posto solo nelle stanze della memoria: quando il mare del tempo le cancellerà dalla terra, esse parleranno a chi siamo stati, per rimettere insieme e dare un senso a tutto quel che non siamo mai riusciti a capire e abbiamo solo potuto accettare; a quelle immagini che da sole non lo avevano e che insieme costituiscono la vita, viaggio di cui saremo noi l’unico, vero e finale testimone.
Il Testimone, Juan José Saer (La Nuova Frontiera, trad. Luisa Pranzetti). Un’opera che si colloca al di là delle frontiere, nata dalla penna di quello che è uno di più grandi scrittori della letteratura in qualsiasi lingua: così ne parla Ricardo Piglia. Con il romanzo in questione, l’autore argentino tesse le trame della vita di un mozzo quindicenne, orfano e solo al mondo, che intraprende il viaggio verso la terra (presunta) vergine delle ancora chiamate “Indie”, per finire rapito insieme ai suoi compagni da una tribù indigena di cannibali; a differenza loro, lui non finirà sulla graticola. Con descrizioni minuziose, raccontate con un linguaggio preciso, che attinge a un lessico e a strutture che rendono la lettura avvolgente, l’Io narrante anziano ripercorre quegli anni di osservazione e i sentieri che da lì si sono aperti durante il suo vagare in un deserto secco, indefinito e calcinato, per parlare a chi legge dell’esperienza umana, delle impronte dei suoi passi e delle sue cadute, percorso al quale spetta un posto solo nelle stanze della memoria: quando il mare del tempo le cancellerà dalla terra, esse parleranno a chi siamo stati, per rimettere insieme e dare un senso a tutto quel che non siamo mai riusciti a capire e abbiamo solo potuto accettare; a quelle immagini che da sole non lo avevano e che insieme costituiscono la vita, viaggio di cui saremo noi l’unico, vero e finale testimone.
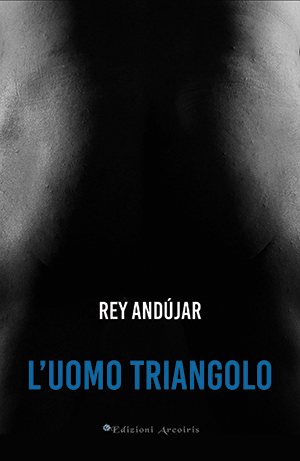 L’uomo triangolo, Rey Andújar (Edizioni Arcoiris, trad. Barbara Flak Stizzoli). In una Santo Domingo piovosa quanto asciutta, si muove il Tenente Pérez, ufficiale dell’esercito, machista e autoritario, con al seguito i suoi fedelissimi soldati che seguono le sue direttive con devozione. Definendone i contorni, Andújar non vuole creare un eroe: la sua quotidianità e il suo atteggiamento non costituiscono alcuna eccezionalità rispetto, se così lo si vuole intendere, allo stereotipo dell’uomo d’armi e si inseriscono nel contesto che fa da sfondo alla vicenda. In un giorno qualunque, nel suo ufficio finisce Baraka, uomo fermato perché correva nudo per le strade: si fa chiamare l’Uomo triangolo. L’incontro con questa misteriosa figura scaturisce la discesa del protagonista nel suo inferno interiore, fatto di morte, violenza e lutto, peccati da espiare; egli brama la morte, ma chiede salvezza. Nel suo processo di decostruzione del protagonista, Andújar riconsegna un romanzo fisico e materiale che ripercorre le geografie ferite dei corpi che lo attraversano. Pérez; Rotunda, una prostituta che emigrerà alla volta dell’Europa in cerca di una fortuna che non troverà; Baraka, un “pazzo” che parlava di amore; infine Santo Domingo che osserva il suo inarrestabile e diffuso declino.
L’uomo triangolo, Rey Andújar (Edizioni Arcoiris, trad. Barbara Flak Stizzoli). In una Santo Domingo piovosa quanto asciutta, si muove il Tenente Pérez, ufficiale dell’esercito, machista e autoritario, con al seguito i suoi fedelissimi soldati che seguono le sue direttive con devozione. Definendone i contorni, Andújar non vuole creare un eroe: la sua quotidianità e il suo atteggiamento non costituiscono alcuna eccezionalità rispetto, se così lo si vuole intendere, allo stereotipo dell’uomo d’armi e si inseriscono nel contesto che fa da sfondo alla vicenda. In un giorno qualunque, nel suo ufficio finisce Baraka, uomo fermato perché correva nudo per le strade: si fa chiamare l’Uomo triangolo. L’incontro con questa misteriosa figura scaturisce la discesa del protagonista nel suo inferno interiore, fatto di morte, violenza e lutto, peccati da espiare; egli brama la morte, ma chiede salvezza. Nel suo processo di decostruzione del protagonista, Andújar riconsegna un romanzo fisico e materiale che ripercorre le geografie ferite dei corpi che lo attraversano. Pérez; Rotunda, una prostituta che emigrerà alla volta dell’Europa in cerca di una fortuna che non troverà; Baraka, un “pazzo” che parlava di amore; infine Santo Domingo che osserva il suo inarrestabile e diffuso declino.
 83 romanzi, Alberto Chimal (pièdimosca edizioni, trad. Loris Tassi). Un’avventura letteraria in cui porta con sé la sua capacità di narrare mondi e accoglie la sfida di condensare tali narrazioni in uno spazio di esistenza che non supera il numero di caratteri imposti da un tweet, che in un quadro più ampio rappresenta l’ultima frontiera di un genere, la microfinzione, mai uguale a sé stessa, in grado di viaggiare da un medium all’altro e frequentato in America Latina. La raccolta è parte di un progetto altrettanto interessante, dirottato a margine da Carlo Sperduti, per pièdimosca edizioni, la collana Glossa, che accoglie l’autore messicano, tra i più noti e innovativi che la letteratura abbia mai conosciuto che si riconferma nella sua abilità di dipingere quadri capaci di accompagnare il lettore in molteplici mondi, che possono essere dimensioni sconosciute e inesplorate piuttosto che dargli la possibilità di accedere a punti di vista differenti (e non è poco), vuole riconsegnare a chi legge una raccolta di testi, che si interrogano su – come scrive Luciano Funetta nel suo Domicilio sconosciuto – “il complesso rapporto che la letteratura ha o dovrebbe avere con il reale”, e sovrappongono un esercizio di immaginazione, nello spazio di una riga quanto nel loro non detto, alla rappresentazione della realtà umana, ritratta dalla prospettiva delle sue conquiste e delle sue più o meno banali perdite; delle sue paure, dei suoi sentimenti, pulsioni e ossessioni, svelando il miraggio che quei personaggi mai nominati, mai definiti, inseguono: tenere stretto in un pugno il segreto del mondo.
83 romanzi, Alberto Chimal (pièdimosca edizioni, trad. Loris Tassi). Un’avventura letteraria in cui porta con sé la sua capacità di narrare mondi e accoglie la sfida di condensare tali narrazioni in uno spazio di esistenza che non supera il numero di caratteri imposti da un tweet, che in un quadro più ampio rappresenta l’ultima frontiera di un genere, la microfinzione, mai uguale a sé stessa, in grado di viaggiare da un medium all’altro e frequentato in America Latina. La raccolta è parte di un progetto altrettanto interessante, dirottato a margine da Carlo Sperduti, per pièdimosca edizioni, la collana Glossa, che accoglie l’autore messicano, tra i più noti e innovativi che la letteratura abbia mai conosciuto che si riconferma nella sua abilità di dipingere quadri capaci di accompagnare il lettore in molteplici mondi, che possono essere dimensioni sconosciute e inesplorate piuttosto che dargli la possibilità di accedere a punti di vista differenti (e non è poco), vuole riconsegnare a chi legge una raccolta di testi, che si interrogano su – come scrive Luciano Funetta nel suo Domicilio sconosciuto – “il complesso rapporto che la letteratura ha o dovrebbe avere con il reale”, e sovrappongono un esercizio di immaginazione, nello spazio di una riga quanto nel loro non detto, alla rappresentazione della realtà umana, ritratta dalla prospettiva delle sue conquiste e delle sue più o meno banali perdite; delle sue paure, dei suoi sentimenti, pulsioni e ossessioni, svelando il miraggio che quei personaggi mai nominati, mai definiti, inseguono: tenere stretto in un pugno il segreto del mondo.
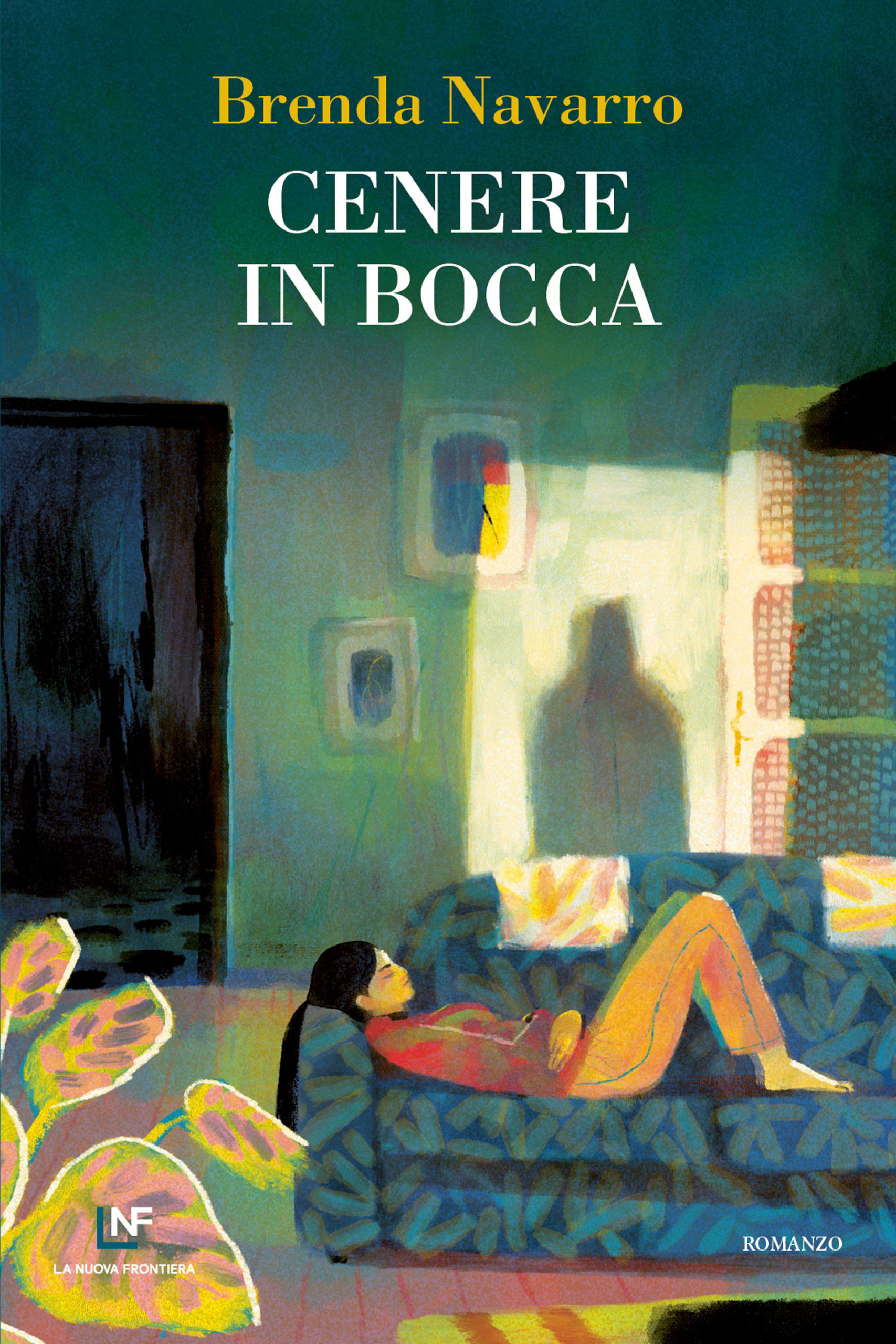 Cenere in bocca, Brenda Navarro (La Nuova Frontiera, trad. Gina Maneri). Nella sua raccolta, Puttane assassine, dell’autore cileno Roberto Bolaño, figura un racconto, “Giorni del 1978”, rotante attorno alla sfuggente figura di “U”. La narrazione ha un tragico epilogo: U viene trovato morto, il suo corpo penzoloni dal ramo di un albero sperduto in un bosco dimenticato, appeso a quella cravatta che era solito portare. Si è suicidato. Ma non è la fine della storia il punto centrale, in questa sede, quanto più un fattore che ha scolpito un ricordo indelebile nella mente di chi scrive: che tale finale diventa palese circa a metà del testo. Mentre chi legge spera che l’autore possa salvarlo e impantanato nelle domande che assediano chi osserva qualcuno affogare in sé stesso, Bolaño chiede silenzio. È ciò che chiede Navarro nel suo Cenere in bocca. A partire dalla morte di suo fratello Diego, l’autrice messicana ripercorre una storia di emigrazione, di volti che cambiano e non si riconoscono, delle bugie per sopravvivere, di un riscatto che non ci sarà. Alfonsina Storni scriveva Si rompono i bicchieri e il vetro che resta /è cenere per sempre e per sempre sarà! (trad. mia) ma se i personaggi di Navarro non troveranno mai il loro posto nel mondo, la letteratura che prende forma tra le pagine di Cenere in bocca glielo darà, glielo darà nel dolore che scandisce vite che – come dice Zerocalcare – sono pile di fogli stropicciati: gettati nel fuoco riescono comunque a scaldare; a volte questo basta, altre no.
Cenere in bocca, Brenda Navarro (La Nuova Frontiera, trad. Gina Maneri). Nella sua raccolta, Puttane assassine, dell’autore cileno Roberto Bolaño, figura un racconto, “Giorni del 1978”, rotante attorno alla sfuggente figura di “U”. La narrazione ha un tragico epilogo: U viene trovato morto, il suo corpo penzoloni dal ramo di un albero sperduto in un bosco dimenticato, appeso a quella cravatta che era solito portare. Si è suicidato. Ma non è la fine della storia il punto centrale, in questa sede, quanto più un fattore che ha scolpito un ricordo indelebile nella mente di chi scrive: che tale finale diventa palese circa a metà del testo. Mentre chi legge spera che l’autore possa salvarlo e impantanato nelle domande che assediano chi osserva qualcuno affogare in sé stesso, Bolaño chiede silenzio. È ciò che chiede Navarro nel suo Cenere in bocca. A partire dalla morte di suo fratello Diego, l’autrice messicana ripercorre una storia di emigrazione, di volti che cambiano e non si riconoscono, delle bugie per sopravvivere, di un riscatto che non ci sarà. Alfonsina Storni scriveva Si rompono i bicchieri e il vetro che resta /è cenere per sempre e per sempre sarà! (trad. mia) ma se i personaggi di Navarro non troveranno mai il loro posto nel mondo, la letteratura che prende forma tra le pagine di Cenere in bocca glielo darà, glielo darà nel dolore che scandisce vite che – come dice Zerocalcare – sono pile di fogli stropicciati: gettati nel fuoco riescono comunque a scaldare; a volte questo basta, altre no.
 Territorio di fuga, Sara Bertrand (Edicola Ediciones, trad. Giulia Giorgini). A Lili piacciono i classici di Tolkien, ha un naso sporgente a causa di una caduta e vuole bene ai suoi nonni. La nonna N1, però, è occupata nelle sue chiacchiere con le amiche, sedute a un tavolino impolverato, tra le buste colme di oggetti che non potrebbe permettersi e i denti gialli di nicotina, il portafogli sempre vuoto. Il nonno passa le sue giornate in una biblioteca, sua fortezza inespugnabile, a protezione della quale c’è una Calibro 45. Il padre distaccato, la madre è andata via. I primi amori e le prime volte senza senso o nome; poi l’amore quello vero e la paura di aprirgli le porte. Con una scrittura crudele alla ricerca di un briciolo di tenerezza, che risiede in uno sguardo o nel raggio di sole che entra dalla finestra, l’autrice dipinge il ritratto di una bambina e poi donna prigioniera in un reticolato di fughe fallite, in cui si è ritrovata senza volerlo, facendo i conti con la rabbia, la fragilità, l’egoismo e la mancanza di responsabilità degli adulti che aveva intorno, per passare a un’età adulta, con la pelle segnata da quelle ferite che ancora sanguinano, mai rimarginate; Bertrand non vuole puntare il dito, bensì prova a rappresentare la condanna derivata da quei traumi irrisolti che vomitano giovani adulti in un mondo in cui cercano di sopravvivere come possono, nel tentativo di sbrogliare le loro matasse, rincollando costantemente i pezzi sfuggenti di vetro di una caduca serenità, ogni giorno con la paura di dover ricominciare da capo, ogni giorno con la consapevolezza che sarà sempre più difficile ricomporre un vaso difettoso in partenza, alle prese con la difficoltà di aprire il proprio cuore a quanto di bello può ancora salvarli, per permettergli di tracciare, tra gli arzigogolati sentieri di fughe fallite, un percorso verso una casa dove non sarà più necessario scappare.
Territorio di fuga, Sara Bertrand (Edicola Ediciones, trad. Giulia Giorgini). A Lili piacciono i classici di Tolkien, ha un naso sporgente a causa di una caduta e vuole bene ai suoi nonni. La nonna N1, però, è occupata nelle sue chiacchiere con le amiche, sedute a un tavolino impolverato, tra le buste colme di oggetti che non potrebbe permettersi e i denti gialli di nicotina, il portafogli sempre vuoto. Il nonno passa le sue giornate in una biblioteca, sua fortezza inespugnabile, a protezione della quale c’è una Calibro 45. Il padre distaccato, la madre è andata via. I primi amori e le prime volte senza senso o nome; poi l’amore quello vero e la paura di aprirgli le porte. Con una scrittura crudele alla ricerca di un briciolo di tenerezza, che risiede in uno sguardo o nel raggio di sole che entra dalla finestra, l’autrice dipinge il ritratto di una bambina e poi donna prigioniera in un reticolato di fughe fallite, in cui si è ritrovata senza volerlo, facendo i conti con la rabbia, la fragilità, l’egoismo e la mancanza di responsabilità degli adulti che aveva intorno, per passare a un’età adulta, con la pelle segnata da quelle ferite che ancora sanguinano, mai rimarginate; Bertrand non vuole puntare il dito, bensì prova a rappresentare la condanna derivata da quei traumi irrisolti che vomitano giovani adulti in un mondo in cui cercano di sopravvivere come possono, nel tentativo di sbrogliare le loro matasse, rincollando costantemente i pezzi sfuggenti di vetro di una caduca serenità, ogni giorno con la paura di dover ricominciare da capo, ogni giorno con la consapevolezza che sarà sempre più difficile ricomporre un vaso difettoso in partenza, alle prese con la difficoltà di aprire il proprio cuore a quanto di bello può ancora salvarli, per permettergli di tracciare, tra gli arzigogolati sentieri di fughe fallite, un percorso verso una casa dove non sarà più necessario scappare.
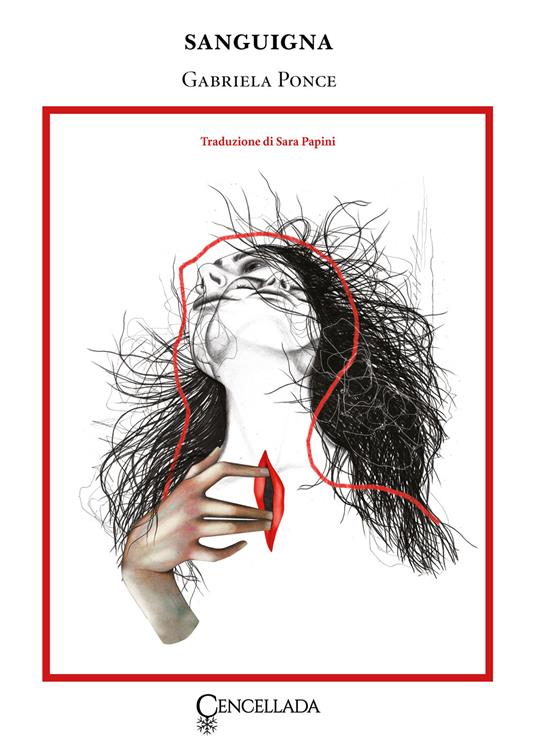 Sanguigna, Gabriela Ponce (Cencellada Edizioni, trad. Sara Papini). Con Sanguigna, edito da Cencellada Edizioni nella traduzione di Sara Papini, Ponce dà prova di una penna piena, sapiente, riconsegnando il perfetto ritratto del periodo successivo a una frattura amorosa: dopo anni di condivisione e progetti, il matrimonio tra la protagonista e suo marito, anch’egli senza nome, è giunto al termine, per lasciare spazio al racconto di una donna alle prese con il dolore di quelle assenze che continuano a tornare, dalle camicie che si intravedono nell’oscurità dell’armadio ai piccoli lampi che infrangono la monotonia di un istante, mentre si destreggia tra le piccole azioni quotidiane, il lavoro, le visite ai genitori, per sopravvivere al tempo e incontri occasionali con altri uomini. Si finisce per ritrovarsi in una costellazione che riunisce amore, assenza, dolore e desiderio, in un racconto che si alterna tra i ricordi della vita matrimoniale e dei rapporti fugaci e il tempo presente, non per scandirne il tempo, bensì per creare una sorta di realtà in simultanea in grado di dare vita a una narrazione in prima persona, fluida, ma terrosa, che si sviluppa sullo sfondo degli spazi che compongono il romanzo, in cui lo sguardo della donna si perde, per aggrapparsi infine a un compendio di forme imperfette, frastagliate e fallibili e di oggetti che scorrono insieme sul letto di un fiume impetuoso, il cui flusso smuove i detriti di un passato depositatisi al di sotto di pensieri che invece viaggiano liberi, alla ricerca di una perduta organicità.
Sanguigna, Gabriela Ponce (Cencellada Edizioni, trad. Sara Papini). Con Sanguigna, edito da Cencellada Edizioni nella traduzione di Sara Papini, Ponce dà prova di una penna piena, sapiente, riconsegnando il perfetto ritratto del periodo successivo a una frattura amorosa: dopo anni di condivisione e progetti, il matrimonio tra la protagonista e suo marito, anch’egli senza nome, è giunto al termine, per lasciare spazio al racconto di una donna alle prese con il dolore di quelle assenze che continuano a tornare, dalle camicie che si intravedono nell’oscurità dell’armadio ai piccoli lampi che infrangono la monotonia di un istante, mentre si destreggia tra le piccole azioni quotidiane, il lavoro, le visite ai genitori, per sopravvivere al tempo e incontri occasionali con altri uomini. Si finisce per ritrovarsi in una costellazione che riunisce amore, assenza, dolore e desiderio, in un racconto che si alterna tra i ricordi della vita matrimoniale e dei rapporti fugaci e il tempo presente, non per scandirne il tempo, bensì per creare una sorta di realtà in simultanea in grado di dare vita a una narrazione in prima persona, fluida, ma terrosa, che si sviluppa sullo sfondo degli spazi che compongono il romanzo, in cui lo sguardo della donna si perde, per aggrapparsi infine a un compendio di forme imperfette, frastagliate e fallibili e di oggetti che scorrono insieme sul letto di un fiume impetuoso, il cui flusso smuove i detriti di un passato depositatisi al di sotto di pensieri che invece viaggiano liberi, alla ricerca di una perduta organicità.
 El Palomar, Francisco Magallanes (Edizioni Arcoiris, trad. Raul Schenardi). Nel Palomar – la piccionaia – tutto ciò che si poteva fare era guidare e ballare. Di giorno, i ragazzi del quartiere, amici di infanzia, si trovavano nelle remiserías, agenzie private di noleggio veicoli, guidando per pochissimi spicci – a volte neanche quelli – le automobili lavate abusivamente nel parcheggio dell’Avvocato; di notte si radunavano tra gli striscioni – che a Smilzo piaceva tanto dipingere – delle tifoserie delle due squadre che competono nello stadio della città, per ritrovarsi poi nei malmessi bar, cercando di incrociare lo sguardo delle ragazze sedute al bancone. Lì suonava la cumbia villera, bella e da ballare abbracciati. Infine la vita che proseguiva tra una placida staticità e un frustrante immobilismo, tra l’obbligata necessità di dover sopravvivere grazie a quei lavori rimediati e il desiderio di fare il salto, per cambiare vita, come aveva provato a fare Pompy, entrato in un giro di affari che forse lo avrebbe fatto diventare il capo degli Ultras o aiutato ad arricchirsi, peccato però per quell’atto di “strafottenza” verso quel poliziotto che gli ha puntato la pistola, per portarlo poi in Canada (in prigione). Spazi che vivono «un processo di simbiosi, di amalgama, di trasmutazioni» e di cui Magallanes coglie la loro sfumatura più silenziosa e malinconica, che accompagna lo sviluppo dei personaggi lungo tutta la vicenda, osservando le loro turbe, ammirandone le speranze e gli slanci. Sfumatura che in qualche modo anche l’autore fa propria, scegliendo di spogliarsi del ruolo di narratore, per lasciare ai soli protagonisti e al linguaggio in cui si esprimono la prerogativa di rappresentare la loro realtà e limitarsi dunque a osservarli mentre, arrampicati sulle punte di ferro incrostate nel cemento, si raccontano a un sole ormai stanco, che affoga nel fiume.
El Palomar, Francisco Magallanes (Edizioni Arcoiris, trad. Raul Schenardi). Nel Palomar – la piccionaia – tutto ciò che si poteva fare era guidare e ballare. Di giorno, i ragazzi del quartiere, amici di infanzia, si trovavano nelle remiserías, agenzie private di noleggio veicoli, guidando per pochissimi spicci – a volte neanche quelli – le automobili lavate abusivamente nel parcheggio dell’Avvocato; di notte si radunavano tra gli striscioni – che a Smilzo piaceva tanto dipingere – delle tifoserie delle due squadre che competono nello stadio della città, per ritrovarsi poi nei malmessi bar, cercando di incrociare lo sguardo delle ragazze sedute al bancone. Lì suonava la cumbia villera, bella e da ballare abbracciati. Infine la vita che proseguiva tra una placida staticità e un frustrante immobilismo, tra l’obbligata necessità di dover sopravvivere grazie a quei lavori rimediati e il desiderio di fare il salto, per cambiare vita, come aveva provato a fare Pompy, entrato in un giro di affari che forse lo avrebbe fatto diventare il capo degli Ultras o aiutato ad arricchirsi, peccato però per quell’atto di “strafottenza” verso quel poliziotto che gli ha puntato la pistola, per portarlo poi in Canada (in prigione). Spazi che vivono «un processo di simbiosi, di amalgama, di trasmutazioni» e di cui Magallanes coglie la loro sfumatura più silenziosa e malinconica, che accompagna lo sviluppo dei personaggi lungo tutta la vicenda, osservando le loro turbe, ammirandone le speranze e gli slanci. Sfumatura che in qualche modo anche l’autore fa propria, scegliendo di spogliarsi del ruolo di narratore, per lasciare ai soli protagonisti e al linguaggio in cui si esprimono la prerogativa di rappresentare la loro realtà e limitarsi dunque a osservarli mentre, arrampicati sulle punte di ferro incrostate nel cemento, si raccontano a un sole ormai stanco, che affoga nel fiume.
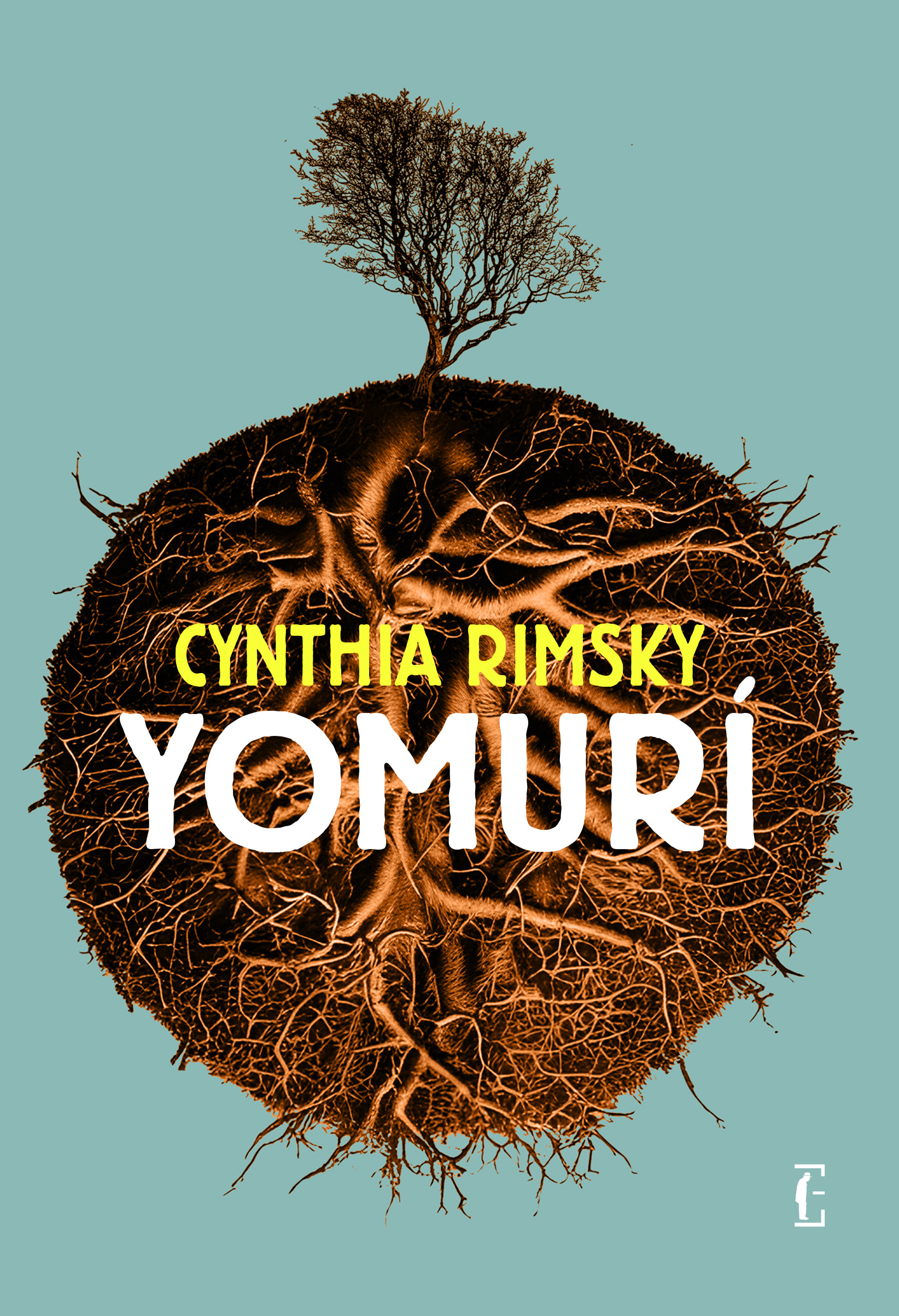 Yomurí, Cynthia Rimsky (Edicola Ediciones, trad. Silvia Farloni). Yomurí rappresenta la destinazione finale, così come il romanzo dell’autrice cilena Cynthia Rimsky, dall’omonimo titolo, rappresenta il culmine di un processo di scrittura durato anni prima di arrivare alla sua effettiva pubblicazione, avvenuta recentemente anche in Italia nella traduzione di Silvia Farloni, grazie alla casa editrice Edicola Ediciones. Il tempo è qualcosa che la scrittura di Cynthia Rimsky, in questo romanzo, assapora fino all’ultimo: non vi è fretta alcuna, né la smania di lasciare che la narrazione incalzi o esploda; non cerca di dare a chi legge il colpo di scena che sta cercando. Al contrario, l’autrice cilena riveste queste pagine di dettagli mai ridondanti, per restituire una narrazione stratificata in cui unisce l’esperienza personale dei suoi personaggi a questioni di natura sociale molto importanti, non come fossero due entità distinte e separate, ma come due aspetti in continua comunicazione. Da un lato abbiamo una figlia di fronte a un padre, un uomo anziano con tutte le sue colpe; dall’altra il bene di una donna ormai adulta e in una relazione difficile, che cerca il perdono, nonostante un passato di assenza continui a tornare. Ci sono due ragazzi che sono troppo giovani per amare. Una donna tra le strade deserte del Cile che parla dei fardelli che ognuno si porta sulle spalle, tanto quanto della bellezza della comunità, della possibilità di recuperare insieme. Poi ci sono i diritti e le lotte sempre vive, mai scontate, che diventano comuni, per proteggere la propria casa dallo sfruttamento, per creare poi una casa comune. E nell’avventura che unisce i percorsi dei protagonisti tracciati nel romanzo, il loro viaggio verso Yomurí diventa la metafora di sé stessi, un viaggio alla ricerca della strada di casa, quel luogo reale quanto interiore, in cui persino i cuori più irrequieti trovano la loro pacificazione.
Yomurí, Cynthia Rimsky (Edicola Ediciones, trad. Silvia Farloni). Yomurí rappresenta la destinazione finale, così come il romanzo dell’autrice cilena Cynthia Rimsky, dall’omonimo titolo, rappresenta il culmine di un processo di scrittura durato anni prima di arrivare alla sua effettiva pubblicazione, avvenuta recentemente anche in Italia nella traduzione di Silvia Farloni, grazie alla casa editrice Edicola Ediciones. Il tempo è qualcosa che la scrittura di Cynthia Rimsky, in questo romanzo, assapora fino all’ultimo: non vi è fretta alcuna, né la smania di lasciare che la narrazione incalzi o esploda; non cerca di dare a chi legge il colpo di scena che sta cercando. Al contrario, l’autrice cilena riveste queste pagine di dettagli mai ridondanti, per restituire una narrazione stratificata in cui unisce l’esperienza personale dei suoi personaggi a questioni di natura sociale molto importanti, non come fossero due entità distinte e separate, ma come due aspetti in continua comunicazione. Da un lato abbiamo una figlia di fronte a un padre, un uomo anziano con tutte le sue colpe; dall’altra il bene di una donna ormai adulta e in una relazione difficile, che cerca il perdono, nonostante un passato di assenza continui a tornare. Ci sono due ragazzi che sono troppo giovani per amare. Una donna tra le strade deserte del Cile che parla dei fardelli che ognuno si porta sulle spalle, tanto quanto della bellezza della comunità, della possibilità di recuperare insieme. Poi ci sono i diritti e le lotte sempre vive, mai scontate, che diventano comuni, per proteggere la propria casa dallo sfruttamento, per creare poi una casa comune. E nell’avventura che unisce i percorsi dei protagonisti tracciati nel romanzo, il loro viaggio verso Yomurí diventa la metafora di sé stessi, un viaggio alla ricerca della strada di casa, quel luogo reale quanto interiore, in cui persino i cuori più irrequieti trovano la loro pacificazione.
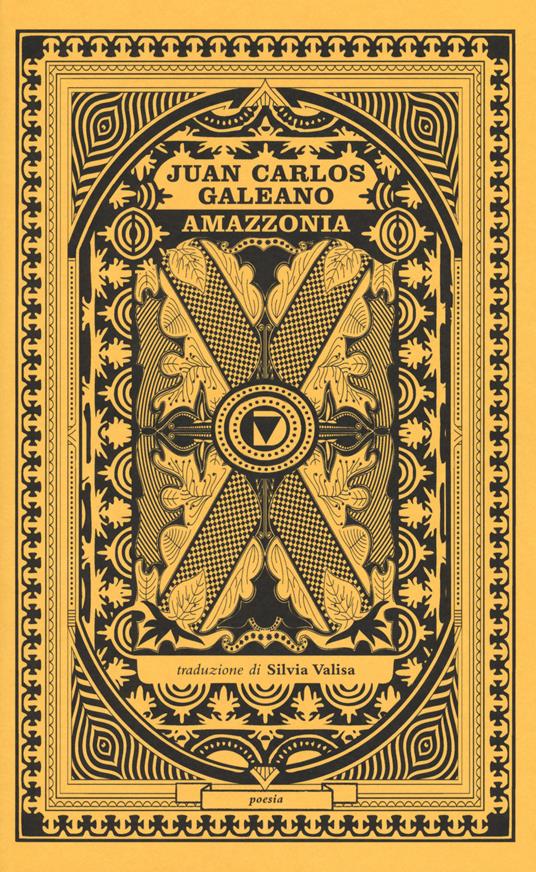 Amazzonia, Juan Carlos Galeano (Del Vecchio Editore, trad. Silvia Valisa). È un compendio di immagini, la raccolta di poesie dell’autore colombiano, le quali sono avvolte nell’abbraccio dato dall’immagine principale che le contestualizza, ma al contempo ne amplifica il significato: l’Amazzonia. In un percorso che prende le mosse dal racconto delle “divinità”, del rapporto di reciprocità che unisce le comunità che abitano la grande foresta pluviale con l’ambiente a esse circostante, Galeano riconsegna a chi legge il multiforme ritratto dell’esperienza umana, protagonista silenziosa – talvolta non nominata – di poesie popolate da animali, rotanti attorno elementi naturali, narrate da una struttura in versi sapientemente costruita dall’autore, il quale si è definito – alla mia domanda – un imagista, dunque che guarda all’essenzialità della parola, da cui estrae il suono che genera l’immagine che si fa veicolo di messaggi importanti, quali il feroce sfruttamento di queste distese verdi che ha decimato popoli interi e che a lungo andare avrà conseguenze irreparabili anche per coloro che si sentono assolti. È a questa umanità recisa, sempre più sola e impoverita, a cui si rivolge, cercando di avvolgerla nell’universo da egli rappresentato percorrendo la scia del dolore umano; nei componimenti che parlano di tale argomento, lo sguardo del poeta si rivolge a oggetti senza vita, mentre intorno descrive una natura che fa il suo corso; che non sia in questa processualità che accomuna il mistero della cura ai misteri naturali che possano riscoprirsi le trame di un appartenere.
Amazzonia, Juan Carlos Galeano (Del Vecchio Editore, trad. Silvia Valisa). È un compendio di immagini, la raccolta di poesie dell’autore colombiano, le quali sono avvolte nell’abbraccio dato dall’immagine principale che le contestualizza, ma al contempo ne amplifica il significato: l’Amazzonia. In un percorso che prende le mosse dal racconto delle “divinità”, del rapporto di reciprocità che unisce le comunità che abitano la grande foresta pluviale con l’ambiente a esse circostante, Galeano riconsegna a chi legge il multiforme ritratto dell’esperienza umana, protagonista silenziosa – talvolta non nominata – di poesie popolate da animali, rotanti attorno elementi naturali, narrate da una struttura in versi sapientemente costruita dall’autore, il quale si è definito – alla mia domanda – un imagista, dunque che guarda all’essenzialità della parola, da cui estrae il suono che genera l’immagine che si fa veicolo di messaggi importanti, quali il feroce sfruttamento di queste distese verdi che ha decimato popoli interi e che a lungo andare avrà conseguenze irreparabili anche per coloro che si sentono assolti. È a questa umanità recisa, sempre più sola e impoverita, a cui si rivolge, cercando di avvolgerla nell’universo da egli rappresentato percorrendo la scia del dolore umano; nei componimenti che parlano di tale argomento, lo sguardo del poeta si rivolge a oggetti senza vita, mentre intorno descrive una natura che fa il suo corso; che non sia in questa processualità che accomuna il mistero della cura ai misteri naturali che possano riscoprirsi le trame di un appartenere.
 (D)istruzioni d’uso per una macchina da cucire, Eugenia Prado Bassi (Edicola Ediciones, trad. Laura Scarabelli). Un romanzo costituito da una serie di sezioni che la penna decisa quanto delicata di Eugenia Prado Bassi cuce insieme, quasi fossero trame di tessuto che ricostruiscono la realtà di un universo, quello femminile, che in maniera lenta ma continua ancora sanguina. Il libro origina da uno strumento, la macchina da cucire, il quale si ritaglia uno spazio di ambiguità in quanto la sua introduzione ha significato la possibilità per le donne di abbandonare le mura domestiche, per portare il loro lavoro di sarte nei laboratori dove, però, erano sottoposti a turni stremanti, per i quali percepivano uno stipendio da fame; sulla scia di ciò, l’autrice cilena si approccia a storie di donne che parlano delle suture praticate sulle ferite inferte da una quotidianità di sfruttamento e lavoro malpagato; delle toppe che sono state costrette ad applicare sui loro progetti e sogni. Le pagine di Bassi si caratterizzano per la polifonia data da una narrazione in prima persona, che intreccia in un dialogo non dichiarato le voci di operaie, madri e figlie, dell’esperienza della gravidanza e dell’aborto e si perde in un racconto di solitudine, di paura, del dolore fisico e psicologico causato dall’essere intrappolate in una prigione eterna di diritti negati, che affonda le sue radici in una rete di strutture culturali e di aspettative sociali che gravano sulla loro esistenza come una minaccia costante e silenziosa. Eppure Bassi ritaglia per loro una zona discorsiva e plurale che le vede aggrapparsi all’unico strumento di resistenza che mai gli potrà essere negato: la parola. Quella scritta da Mercedes in un taccuino, decantata sulle sedie del laboratorio. Lo stesso lessico del cucito subisce una risemantizzazione che, mentre svela la realtà di donne che cercano di mantenersi vive nel loro presente, tesse la loro storia di resistenza che risuona con le storie di resistenza che si scrivono da ogni parte del mondo, anche a distanza di tempo, nella speranza che esse possano riuscire un giorno a gridare insieme, per chi non è più, per chi è e chi sarà.
(D)istruzioni d’uso per una macchina da cucire, Eugenia Prado Bassi (Edicola Ediciones, trad. Laura Scarabelli). Un romanzo costituito da una serie di sezioni che la penna decisa quanto delicata di Eugenia Prado Bassi cuce insieme, quasi fossero trame di tessuto che ricostruiscono la realtà di un universo, quello femminile, che in maniera lenta ma continua ancora sanguina. Il libro origina da uno strumento, la macchina da cucire, il quale si ritaglia uno spazio di ambiguità in quanto la sua introduzione ha significato la possibilità per le donne di abbandonare le mura domestiche, per portare il loro lavoro di sarte nei laboratori dove, però, erano sottoposti a turni stremanti, per i quali percepivano uno stipendio da fame; sulla scia di ciò, l’autrice cilena si approccia a storie di donne che parlano delle suture praticate sulle ferite inferte da una quotidianità di sfruttamento e lavoro malpagato; delle toppe che sono state costrette ad applicare sui loro progetti e sogni. Le pagine di Bassi si caratterizzano per la polifonia data da una narrazione in prima persona, che intreccia in un dialogo non dichiarato le voci di operaie, madri e figlie, dell’esperienza della gravidanza e dell’aborto e si perde in un racconto di solitudine, di paura, del dolore fisico e psicologico causato dall’essere intrappolate in una prigione eterna di diritti negati, che affonda le sue radici in una rete di strutture culturali e di aspettative sociali che gravano sulla loro esistenza come una minaccia costante e silenziosa. Eppure Bassi ritaglia per loro una zona discorsiva e plurale che le vede aggrapparsi all’unico strumento di resistenza che mai gli potrà essere negato: la parola. Quella scritta da Mercedes in un taccuino, decantata sulle sedie del laboratorio. Lo stesso lessico del cucito subisce una risemantizzazione che, mentre svela la realtà di donne che cercano di mantenersi vive nel loro presente, tesse la loro storia di resistenza che risuona con le storie di resistenza che si scrivono da ogni parte del mondo, anche a distanza di tempo, nella speranza che esse possano riuscire un giorno a gridare insieme, per chi non è più, per chi è e chi sarà.
Claudia Putzu














