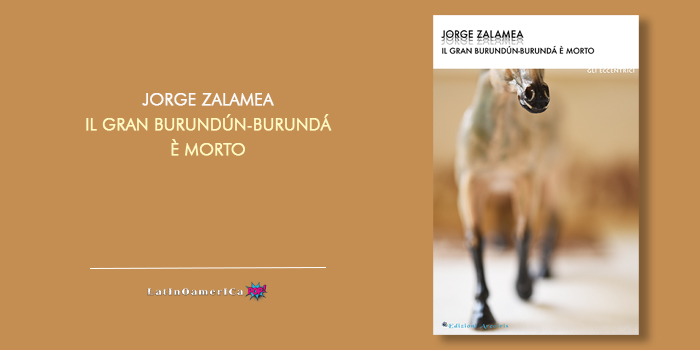Coste vuote, delle quali a rimanere è il ricordo dell’immensità del cielo, della sensazione di essere minuscoli come formiche al centro di un deserto di sabbia; le città di cemento, dove invece la vita è orizzontale, perché tra i loro edifici quell’immenso cielo è nascosto: inizia con queste due immagini, tra loro in contrasto, Il Testimone, nella traduzione italiana di Luisa Pranzetti e che segna il ritorno nel catalogo – con il pocanzi menzionato nuovo titolo e con quella che è una riedizione de L’arcano – della casa editrice romana La Nuova Frontiera, di un autore che Ricardo Piglia ritiene una delle stelle della letteratura mondiale: Juan José Saer.
 Eppure la figura di Juan José Saer fu tutt’altro che popolare, nell’epoca a lui contemporanea. Esordisce nel 1960 con una raccolta di quattordici racconti intitolata En la zona, di cui la critica ci tiene a ricordare principalmente il suo essere distante dall’opera di Jorge Luis Borges, a quel tempo già un punto di riferimento nel panorama culturale argentino; il trovarsi ai margini del canone – e dal mercato letterario – fu il minimo comun denominatore della sua letteratura, estranea all’intenzione di dare prova di una qualche erudizione e non associabile a uno schieramento politico e che si è scritta all’ombra del boom latinoamericano, lontana da ogni sua influenza.
Eppure la figura di Juan José Saer fu tutt’altro che popolare, nell’epoca a lui contemporanea. Esordisce nel 1960 con una raccolta di quattordici racconti intitolata En la zona, di cui la critica ci tiene a ricordare principalmente il suo essere distante dall’opera di Jorge Luis Borges, a quel tempo già un punto di riferimento nel panorama culturale argentino; il trovarsi ai margini del canone – e dal mercato letterario – fu il minimo comun denominatore della sua letteratura, estranea all’intenzione di dare prova di una qualche erudizione e non associabile a uno schieramento politico e che si è scritta all’ombra del boom latinoamericano, lontana da ogni sua influenza.
Non una letteratura da divorare, ma una letteratura in cui dissolversi a poco a poco, scrive così, nel suo puntualissimo articolo uscito su Robinson, inserto di Repubblica, lo scrittore italiano Luciano Funetta: il racconto de Il testimone non potrebbe iniziare in altri modi se non da queste parole. Da questo verbo, “dissolversi”, ossia il disfacimento di un tutto, concetto attorno al quale ruota il romanzo che racconta la storia di un mozzo di quindici anni, imbarcatosi per raggiungere le tanto decantate Indie e il cui percorso si incrocerà con quello di una comunità indigena di cannibali: i suoi compagni verranno tutti uccisi, mentre lui sarà inglobato tra quelle genti, di cui si raccontano i rituali, la loro convivenza con gli appartenenti ad altre popolazioni, la loro fisicità e quegli sguardi pregni di una consapevolezza che al personaggio, in quel determinato momento della sua vita non gli era dato avere.
Ciò conferisce rilevanza a quello che è l’elemento principale del libro: non il decorso degli eventi, né tantomeno le ambientazioni come spesso succede nella letteratura latinoamericana, bensì il narratore, che coincide con lo stesso protagonista ormai anziano, il quale si abbandona in un viaggio a ritroso nei ricordi di quei giorni passati tra quelle persone.
Lo sguardo e la scrittura di Saer che danno corpo a tale racconto, nelle prime pagine, ricordano i diari di viaggio dei primi esploratori delle terre oltreoceano: l’ignoto è il luogo perfetto in cui far oscillare desiderio e allucinazione; si legge di sirene, di ciclopi che ricalcano la visionarietà che accompagnava i primi marinai e di cui se ne ha prova anche nella lettura dei testi dello stesso Cristoforo Colombo. La coscienza del pericolo di intraprendere la rotta su mari sconosciuti e la fame e l’adrenalina di addentrarsi nelle profondità del Nuovo Mondo camminano insieme. L’incontro, l’osservazione e la descrizione della comunità si avvalgono di una penna incredibilmente – per quanto mai ridondante – minuziosa, tale da richiamare l’accuratezza propria dell’etnografia antropologica per cui si concretizza una narrazione sulla frontiera che traccia una “linea di polvere” tra il mondo dell’osservatore e quello di coloro da egli osservati.
Ho come primo ricordo proprio quello della loro esteriorità. […] Da fuori, sembravano al riparo dal dubbio e dal logorio. Nei primi tempi, mi davano l’impressione di essere la misura esatta che definiva, tra la terra e il cielo, il luogo di ogni cosa […] che quel mondo era fatto per loro […] anche se passavano attraverso zone di confusione, non stonavano. Viene inevitabilmente a delinearsi un contrasto che trascende la storia stessa, quella più superficiale, per cedere il passo all’intrinseca dualità narrativa de Il testimone, attraverso la quale l’autore riconsegna a chi legge l’anatomia di una frattura impossibile tra il protagonista e il mondo circostante, che rivela una storia nella storia, scritta dal dolore, dallo smarrimento e dal senso di sradicamento e abbandono di cui lo sguardo dell’Io narrante si permea e per cui riscopre una vulnerabilità che lo unisce in un dialogo non dichiarato con l’Io narrato, per aiutarlo a riconoscere la mancanza di un riparo dall’indefinito nella voracità del sesso; le assenze nella caducità dei legami stretti lungo il cammino; l’inadeguatezza di fronte a un condannato a morte.
L’essere umano, forse, è in grado di ascoltare la vulnerabilità solo quando essa torna a trovarlo come fosse una vecchia amica, vicina ma così distante da non fare più paura, e con la quale dirigersi sull’orlo di quei, un tempo spaventosi, precipizi, dove ormai scorre il fiume dell’esperienza a colmare il divario che disunisce l’essere.
Saer parla di esperienza, e lo fa nell’unico modo in cui essa può essere rappresentata: con un testo che raggiunge un livello di coesione tale, per cui le immagini acquisiscono quel senso che muove la narrazione, solo se osservate insieme, per tessere una rete di significato in cui, appunto, dissolversi a poco a poco e infine ripercorrere le trame di un viaggio che sono miliardi, seguendo le impronte che si è lasciate lungo il cammino, riassorbite dalle onde del tempo e della memoria, per contemplare nella solitudine di una stanza le risposte che il primo ha dato rispetto a tutto ciò che si è potuto soltanto accettare, a quel peregrinare incessante lungo deserti calcinati, alle cadute; per lasciare alla seconda la prerogativa di ricordarci chi e dove siamo stati nel ritratto immaginario di un terrore immobile, quale è il nostro tortuoso passaggio su questa terra, di cui saremo l’unico e finale Testimone.
Claudia Putzu