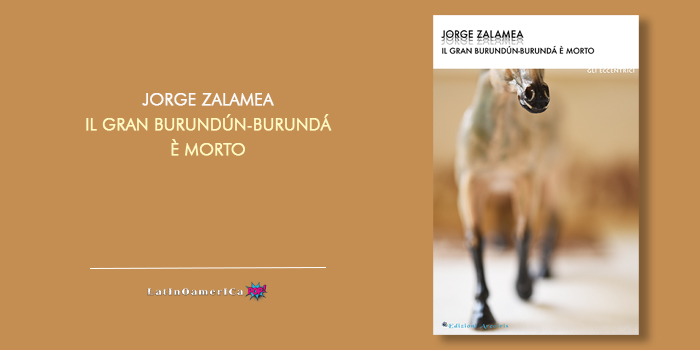“Sono perché gli altri sono stati”.
Chapeo
Ripulire la terra dalle erbacce, questo è il significato che la Real Academia Española attribuisce alla parola “Chapeo”, in questo modo spogliandola del suo significato più profondo, ovvero ciò che – come scrive, nella sua sentita e sempre puntuale introduzione, Raúl Zecca Castel, antropologo e curatore della traduzione – rende alcune parole intraducibili, soprattutto legittimamente proprie di chi le vive e le ha vissute sul proprio corpo, da sempre simbolo del territorio di conquista.
![]() È proprio questa parola a dare il titolo al libro di Johan Mijail, edito in Italia dalle Edizioni Arcoiris. Essa si trasforma in gesto, in un viaggio, un manifesto, un movimento di trasformazione partito dal basso che unisce “coloro che si trovano all’incrocio tra gli assi di oppressione storica, politica ed economica” in un Paese assediato dall’acqua, dalla troppa acqua del Mar dei Caraibi e oppresso da un sole eterno: la Repubblica Dominicana.
È proprio questa parola a dare il titolo al libro di Johan Mijail, edito in Italia dalle Edizioni Arcoiris. Essa si trasforma in gesto, in un viaggio, un manifesto, un movimento di trasformazione partito dal basso che unisce “coloro che si trovano all’incrocio tra gli assi di oppressione storica, politica ed economica” in un Paese assediato dall’acqua, dalla troppa acqua del Mar dei Caraibi e oppresso da un sole eterno: la Repubblica Dominicana.
Nei sette capitoli che compongono Chapeo, Johan Mijail conduce lǝ suǝ lettorǝ lungo le strade di una città in fiamme, Santo Domingo illuminata dalla luce sbiadita di una illusoria modernità, per mostrare il vero volto di un contesto avvolto nella menzogna, di una realtà frammentata i cui contrasti si accentuano nelle descrizioni degli ambienti che si susseguono lungo la narrazione, fermate di un percorso che prende le mosse dai motel della Zona Colonial al Museo del Hombre Dominicano, custodi di un passato coloniale che ha dato inizio a una storia di dolore non ancora conclusa, anzi che prosegue in un presente intriso delle sue logiche etero-normative. In tale contesto, il corpo stesso – se non rientra in quell’ideale «eurosomateca» – costituisce una prigione, ma è da quest’ultimo che Johan Mijail inizia a tessere la trama della sua ribellione, costruendo – riprendo le parole di Preciado – «un soggetto erotico dissidente»: esso diventa predatore, arma di seduzione, per svuotare le tasche dei soggetti egemonici; allo stesso tempo, però, diventa un’entità spirituale, un mezzo attraverso il quale confrontarsi con misteri e loases, attraverso il quale riascoltare le proprie negritudini e riconnettersi con tutti quei corpi non conformi, lasciati ai margini del sistema, insieme per «sputare la rabbia attraverso una poetica antirazzista», per «gridare al cospetto della pervasività del colonialismo».
Leggere Chapeo significa in primis insinuarsi tra le crepe del “paradiso tropicale”, nell’angolo cieco delle fotografie stampate sui dépliant turistici e scorgere le tante realtà sommerse, nascoste, silenziate e relegate nei luoghi più rancidi, corpi senza nome che rivelano su di sé le cicatrici di una violenza strutturale ossia – ci vengono in aiuto le parole usate dallo stesso Raúl Zecca Castel, nella sua introduzione ad America Latina afrodiscendente di Battistessa – “il prodotto di specifiche congiunture storiche, politiche, economiche e sociali determinanti condizioni di radicale e sistemica asimmetria nell’accesso alle risorse fondamentali”.
Ma significa anche assistere a un vero e proprio grido di riaffermazione, di orgogliosa rivendicazione della propria presenza, quello di un mondo plurale, latino, afro, queer, che si traduce in una contro-narrazione «anti-egemonica e materiale, perché riguarda la riappropriazione del potere sul proprio corpo e sui propri desideri», rispetto a una società che queste persone le considera da sempre una vergogna e ha cercato di spogliarle di tutto, mentre viaggia in direzione contraria a quei movimenti sociali di stampo borghese, di cui ne rivela l’ipocrisia. Sulla scia di ciò, quella parola intraducibile, chapeo, diventa materia viva, si riformula e amplifica a identificare un “dispositivo di rivalsa, vera e propria arma a disposizione dei subalterni, per attuare, sia pure temporaneamente, un ribaltamento, o quantomeno una sospensione, delle gerarchie di potere e di dominio”, trasformandosi in una sorta di vendetta, il cui ultimo atto si compie nella sensazione restituita al lettore, una volta che il libro giunge al termine: far sì che, nonostante la forza che le parole lì contenute veicolano venga totalmente percepita, restino comunque inafferrabili.
Ora sta a quest’ultimǝ, non solo il saperle accogliere, senza la pretesa di farle proprie, ma il saperle analizzare con uno spirito critico sufficiente che consenta di “rompere la cornice”, per associarle alle parole di resistenza provenienti dalle crepe della nostra società, dalle più superficiali, fatte delle discriminazioni e della violenza simbolica a cui alcuni gruppi sociali sono silenziosamente esposti, da quegli angoli bui, nascosti e dimenticati, da quei luoghi confinati nell’entroterra, testimoni di violenze e crudeltà inaudite: così la rivoluzione che questo manifesto racchiude in ogni sua parola riuscirà a trascendere i confini, innescando un dispositivo rizomatico, per intrecciarsi con quelle piccole, ma inesorabili rivoluzioni che partono dai margini di ogni singolo angolo del pianeta.
Pubblicare un libro come questo, ancor prima accoglierne la potenza, la sua provocazione significa davvero giocarsela, rischiare, dimostrando che ciò in cui si crede, ciò per cui si sta lavorando vale molto di più di qualsiasi altra cosa. E per il coraggio che muove l’impegno ad amplificare delle parole rivoluzionarie, come quelle di Johan Mijail, che commuovono e disturbano, pregne di significato, in grado di ispirare, bisogna essere grati. Dunque, un ringraziamento doveroso va sicuramente a Raúl Zecca Castel, che si presenta ai suoi lettori in un’altra veste, quella di traduttore, ma con un contributo coerente con il progetto di ricerca che porta avanti da anni, iniziato con Come schiavi in libertà, e alla casa editrice salernitana, Edizioni Arcoiris, che ha accolto la sfida.
Claudia Putzu