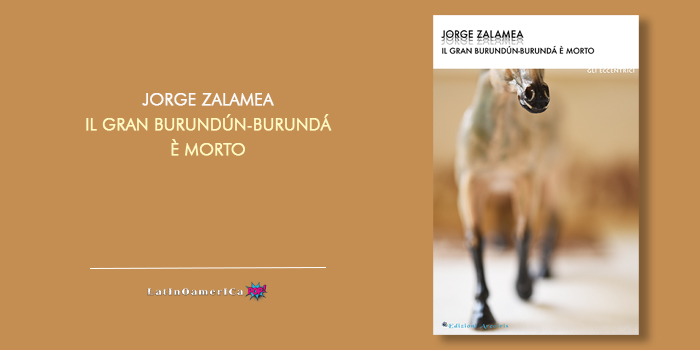Probabilmente non esiste poesia più impressionante e dolorosa di quella di Alejandra Pizarnik. Trasformata in un’icona del femminismo dalle ultime generazioni, imitata nella sua scrittura e persino nel suo modo di vestire (eccentrico, androgino e con i capelli corti), la sua opera ha a lungo dovuto sopportare l’etichetta di essere il frutto della follia, un sintomo che avrebbe prefigurato il tragico epilogo, il suo precoce suicidio, che in realtà ha contribuito ad aumentare il mito. Con il desiderio di incasellare ciò che è inclassificabile, è stata definita la poetessa maledetta dell’America, gotica, surrealista o semplicemente enfant terrible, una stravagante incapace di adattarsi al suo ambiente. Ma né la violenza nelle sue espressioni poetiche né il gusto per esibire immodestamente i suoi fantasmi interiori né la sua riflessione permanente sui confini del linguaggio sono state imposture. La franchezza, l’onestà nell’impegno verso la propria opera, sono indiscutibili. Come disse Octavio Paz nell’introduzione a Árbol de Diana, i suoi poemi non contengono nemmeno una sola particella di menzogna. Disegnano il profilo di una femminilità non convenzionale, posseduta da una passione estrema, capace di “scrivere con il suo corpo il corpo del poema”, di fronte a una società dalla quale si è sempre sentita esclusa e che alla fine avrebbe finito per reclutarla. Alla fine, la sua trasgressione consisteva solo nella ricerca della propria identità, quindi l’ha sperimentata attraverso vari nomi che ha abbandonato (come Flora o Alexandra) per costruire nella vita reale il proprio personaggio o, forse, le maschere di molteplici individualità. Lei scelse di vivere nella parola e questo significò nascondersi nel linguaggio, forse per rifugiarsi in esso.
 Nata ad Avellaneda, un sobborgo portuale e industriale di Buenos Aires, che probabilmente è entrato in conflitto con il suo carattere fantasioso, la sua sensibilità sempre al limite dell’agitazione e il suo implacabile desiderio di raggiungere rilevanza nella letteratura, Alejandra Pizarnik parlava diverse lingue fin da piccola, perché i suoi genitori erano immigrati ebrei, gioiellieri e ben integrati nella comunità ashkenazita, ma, come tanti altri, provenienti da una famiglia vittima dell’Olocausto, i cui sopravvissuti si sono dispersi per il mondo, stabilendosi, ad esempio, in Francia. Al suo sentimento di estraneità, accentuato dal fatto di parlare spagnolo con accento europeo, ha aggiunto nell’adolescenza una serie di complessi che esacerbavano le sue differenze e la sua continua insoddisfazione con l’ambiente circostante, sia per l’acne, l’asma, il balbettio o per una certa tendenza all’aumento di peso. Quest’ultima divenne un’ossessione che la portò a prendere anfetamine, il che sfociò in una dipendenza alternata con l’uso di barbiturici e altri stupefacenti. Ma non furono le sue circostanze di vita, dopotutto non così avverse, a forgiare la sua ribellione. Scrivere era per lei riparare quella ferita fondamentale che ci scava tutti (sebbene ognuno scelga il proprio posto), significava suturare quella breccia che ci impedisce di coincidere con noi stessi per trovare la pienezza del nostro essere. Se il suo impegno per la poesia era totale, è perché lì ha trovato la guarigione, trasfigurando il dolore in bellezza.
Nata ad Avellaneda, un sobborgo portuale e industriale di Buenos Aires, che probabilmente è entrato in conflitto con il suo carattere fantasioso, la sua sensibilità sempre al limite dell’agitazione e il suo implacabile desiderio di raggiungere rilevanza nella letteratura, Alejandra Pizarnik parlava diverse lingue fin da piccola, perché i suoi genitori erano immigrati ebrei, gioiellieri e ben integrati nella comunità ashkenazita, ma, come tanti altri, provenienti da una famiglia vittima dell’Olocausto, i cui sopravvissuti si sono dispersi per il mondo, stabilendosi, ad esempio, in Francia. Al suo sentimento di estraneità, accentuato dal fatto di parlare spagnolo con accento europeo, ha aggiunto nell’adolescenza una serie di complessi che esacerbavano le sue differenze e la sua continua insoddisfazione con l’ambiente circostante, sia per l’acne, l’asma, il balbettio o per una certa tendenza all’aumento di peso. Quest’ultima divenne un’ossessione che la portò a prendere anfetamine, il che sfociò in una dipendenza alternata con l’uso di barbiturici e altri stupefacenti. Ma non furono le sue circostanze di vita, dopotutto non così avverse, a forgiare la sua ribellione. Scrivere era per lei riparare quella ferita fondamentale che ci scava tutti (sebbene ognuno scelga il proprio posto), significava suturare quella breccia che ci impedisce di coincidere con noi stessi per trovare la pienezza del nostro essere. Se il suo impegno per la poesia era totale, è perché lì ha trovato la guarigione, trasfigurando il dolore in bellezza.
Ma quando sentì che la pietra della follia cominciava a rompere il poema, quando intuì che il linguaggio si squarciava in brandelli e la lasciava al freddo, proprio sul limite, Alejandra si offrì alla morte, dopo aver ingerito un potente barbiturico, durante un fine settimana in cui era uscita con il permesso dell’ospedale psichiatrico dove era ricoverata a causa di una depressione. Nel frattempo, la sua scrittura era passata dai poemi-riassunto, brevi pennellate anarchiche senza segni di punteggiatura, ai poemi in prosa, per espandersi infine in quel palinsesto postumo sulla bellezza del sadismo: il suo saggio La contessa sanguinaria. Anche in questo caso, il silenzio non deve essere semplicemente inteso come risultato della morte, perché la violenza del nulla e la sua lacerazione sono ovunque, anche nascosti nel linguaggio, dove la presenza rivela sempre l’assenza. E, tuttavia, nominando si crea il mondo. Perciò, agli ultimi stadi del linguaggio, quando l’accordo e la sincerità hanno dimostrato di essere ideali irrealizzabili, si può solo salvare le ombre e indicare ciò che disassocia e distrugge, per chiarire cosa sia che impedisce la riconciliazione.
 Così fece Alejandra. I suoi temi preferiti sono il silenzio, la morte, la follia… I suoi simboli, ripetuti una e un’altra volta: il vento che disperde l’identità in sospeso, la gabbia, dove si rinchiude la libertà colpevole solo per esistere, quella stessa che, tuttavia, la contiene entro i limiti della realtà e allontana i suoi terrori notturni, perché la notte non ha più il senso accogliente e nutriente che fa nascere il poema. Ora si trasforma in quel momento in cui la paura si nutre e i deliri prendono vita, il luogo dell’impotenza. La bambina che si sentiva come Alice, quella del paese delle meraviglie, capace di attraversare lo specchio solo per continuare la ricerca di un giardino, il suo idilliaco paradiso di giochi, ora si sorprende vedendo il riflesso della propria immagine, la sua ingenuità macchiata da un mondo senza riguardi, dove prospera l’abbandono e la solitudine. Neanche i suoi amori turbolenti, sfortunati o non corrisposti, né la sua bisessualità, rifiutata dalla sua famiglia e mai apertamente riconosciuta, contribuirono alla guarigione. Il suo desiderio di unione, quella passione sfrenata e devastante, la portava inevitabilmente verso ciò che Lacan chiamava strage, restituendole il suo corpo con frustrazione, sotto l’immagine di “una fenditura in una sedia”. Eppure, ci furono periodi deliziosi e divertenti nella sua vita. Ad esempio, quando studiava Lettere all’Università di Buenos Aires, perché, anche se alla fine si divise tra il Giornalismo e le Belle Arti, fu un periodo di letture e dibattiti ferventi. Attraverso il suo professore Juan Jacobo Bajarlía, che l’introdusse nell’ambiente letterario di Buenos Aires e del quale si innamorò senza successo, poté approfondire i suoi poeti preferiti: Artaud, Baudelaire, Rimbaud o Mallarmé, e conoscere i testi dell’Avanguardia. O quando visse a Parigi, dove lavorava come traduttrice e correttrice, anche se questo le dispiaceva perché la distraeva dalla scrittura. Lì si sentì davvero a casa, incoraggiata e protetta da amici scrittori come Cortázar, Octavio Paz, Germán Arciniegas, Italo Calvino, Rosa Chacel o Elvira Orphée. Partecipava a feste e conversazioni con grandi letterati e artisti, passeggiava per il Louvre o si perdeva nello sguardo celeste di Bataille mentre lo incrociava per strada. Pubblicava. Il ritorno a Buenos Aires la riportò alla sua quotidiana inquietudine, anche se lì contava su un ambiente intellettuale accogliente, come la sua amica Olga Orozco o Mujica Láinez, con cui realizzò una mostra dei suoi disegni e delle sue pitture. In quel periodo voleva correggere quella ritirata, ma l’ambita Parigi tanto desiderata all’epoca era già scomparsa tra i movimenti studenteschi del ’68. Perfezionista e competitiva, ottenne le due borse di studio americane più prestigiose per continuare la sua carriera trionfante a New York, ma nemmeno lì si sentì a suo agio. Il suo ritorno definitivo la mise di fronte a quella sua incapacità verso la vita pratica, a quel sentimento di non essere di questo mondo, a due tentativi di suicidio e al suo inferno interiore, dove la coscienza si disperdeva in molteplici voci. Dopo la morte, la sua opera autobiografica subì un destino stravagante. Per metterla al sicuro dalla repressione culturale dello Stato argentino e dai pregiudizi della sua stessa famiglia, che non arrivò mai a comprendere appieno l’importanza di Pizarnik per la letteratura, i Diari viaggiarono da una parte all’altra seguendo le tracce dell’itinerario che la sua autrice aveva segnato in vita. Nascosti durante la dittatura militare a casa di amici a Buenos Aires, furono portati a Parigi per essere custoditi da Cortázar e, in seguito, dalla sua prima moglie, Aurora Bernárdez, fino a quando alla fine furono acquistati dall’Università di Columbia. E tutto questo perché, come ha detto Alejandra:
Così fece Alejandra. I suoi temi preferiti sono il silenzio, la morte, la follia… I suoi simboli, ripetuti una e un’altra volta: il vento che disperde l’identità in sospeso, la gabbia, dove si rinchiude la libertà colpevole solo per esistere, quella stessa che, tuttavia, la contiene entro i limiti della realtà e allontana i suoi terrori notturni, perché la notte non ha più il senso accogliente e nutriente che fa nascere il poema. Ora si trasforma in quel momento in cui la paura si nutre e i deliri prendono vita, il luogo dell’impotenza. La bambina che si sentiva come Alice, quella del paese delle meraviglie, capace di attraversare lo specchio solo per continuare la ricerca di un giardino, il suo idilliaco paradiso di giochi, ora si sorprende vedendo il riflesso della propria immagine, la sua ingenuità macchiata da un mondo senza riguardi, dove prospera l’abbandono e la solitudine. Neanche i suoi amori turbolenti, sfortunati o non corrisposti, né la sua bisessualità, rifiutata dalla sua famiglia e mai apertamente riconosciuta, contribuirono alla guarigione. Il suo desiderio di unione, quella passione sfrenata e devastante, la portava inevitabilmente verso ciò che Lacan chiamava strage, restituendole il suo corpo con frustrazione, sotto l’immagine di “una fenditura in una sedia”. Eppure, ci furono periodi deliziosi e divertenti nella sua vita. Ad esempio, quando studiava Lettere all’Università di Buenos Aires, perché, anche se alla fine si divise tra il Giornalismo e le Belle Arti, fu un periodo di letture e dibattiti ferventi. Attraverso il suo professore Juan Jacobo Bajarlía, che l’introdusse nell’ambiente letterario di Buenos Aires e del quale si innamorò senza successo, poté approfondire i suoi poeti preferiti: Artaud, Baudelaire, Rimbaud o Mallarmé, e conoscere i testi dell’Avanguardia. O quando visse a Parigi, dove lavorava come traduttrice e correttrice, anche se questo le dispiaceva perché la distraeva dalla scrittura. Lì si sentì davvero a casa, incoraggiata e protetta da amici scrittori come Cortázar, Octavio Paz, Germán Arciniegas, Italo Calvino, Rosa Chacel o Elvira Orphée. Partecipava a feste e conversazioni con grandi letterati e artisti, passeggiava per il Louvre o si perdeva nello sguardo celeste di Bataille mentre lo incrociava per strada. Pubblicava. Il ritorno a Buenos Aires la riportò alla sua quotidiana inquietudine, anche se lì contava su un ambiente intellettuale accogliente, come la sua amica Olga Orozco o Mujica Láinez, con cui realizzò una mostra dei suoi disegni e delle sue pitture. In quel periodo voleva correggere quella ritirata, ma l’ambita Parigi tanto desiderata all’epoca era già scomparsa tra i movimenti studenteschi del ’68. Perfezionista e competitiva, ottenne le due borse di studio americane più prestigiose per continuare la sua carriera trionfante a New York, ma nemmeno lì si sentì a suo agio. Il suo ritorno definitivo la mise di fronte a quella sua incapacità verso la vita pratica, a quel sentimento di non essere di questo mondo, a due tentativi di suicidio e al suo inferno interiore, dove la coscienza si disperdeva in molteplici voci. Dopo la morte, la sua opera autobiografica subì un destino stravagante. Per metterla al sicuro dalla repressione culturale dello Stato argentino e dai pregiudizi della sua stessa famiglia, che non arrivò mai a comprendere appieno l’importanza di Pizarnik per la letteratura, i Diari viaggiarono da una parte all’altra seguendo le tracce dell’itinerario che la sua autrice aveva segnato in vita. Nascosti durante la dittatura militare a casa di amici a Buenos Aires, furono portati a Parigi per essere custoditi da Cortázar e, in seguito, dalla sua prima moglie, Aurora Bernárdez, fino a quando alla fine furono acquistati dall’Università di Columbia. E tutto questo perché, come ha detto Alejandra:
“Non voglio andare
oltre
che fino in fondo”.
Virginia Moratiel