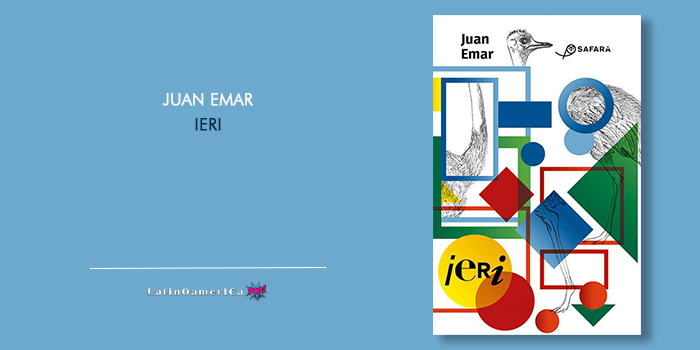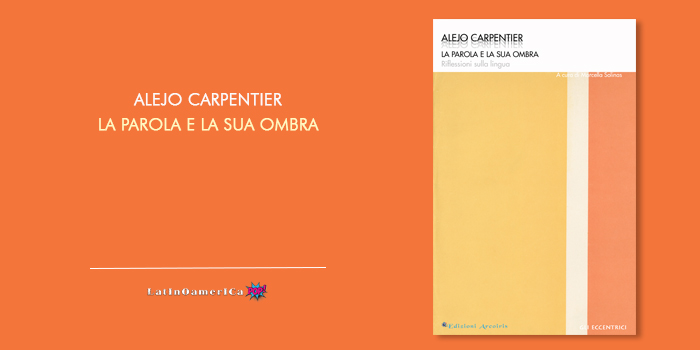Juan Emar, pseudonimo di Álvaro Yáñez (1893-1964), fu una figura controversa nella letteratura cilena degli anni ’20 e ’30 del XX secolo. Proveniente da una famiglia dell’élite cilena, si trovò in una posizione marginale come artista, producendo opere narrative senza precedenti nel panorama letterario del Paese. Sebbene coevo ad avanguardisti come Pablo Neruda e Vicente Huidobro, Emar fu l’unico a dedicarsi esclusivamente alla narrativa in un contesto dominato da poeti e pittori.
Juan Emar, pseudonimo di Álvaro Yáñez (1893-1964), fu una figura controversa nella letteratura cilena degli anni ’20 e ’30 del XX secolo. Proveniente da una famiglia dell’élite cilena, si trovò in una posizione marginale come artista, producendo opere narrative senza precedenti nel panorama letterario del Paese. Sebbene coevo ad avanguardisti come Pablo Neruda e Vicente Huidobro, Emar fu l’unico a dedicarsi esclusivamente alla narrativa in un contesto dominato da poeti e pittori.
La sua attività pubblica iniziò nel 1923 con articoli d’arte su “La Nación”, giornale di proprietà del padre, Eliodoro Yáñez. Attraverso sezioni come “Notas de Arte” e “Notas de París”, promosse l’arte moderna e sostenne l’avanguardia, ma interruppe questa attività nel 1927 dopo l’espropriazione del giornale da parte del governo cileno.
Dal 1935 al 1937 pubblicò tre romanzi (Ieri, Un Año e Miltín 1934) e una raccolta di racconti (Diez), opere che non ricevettero grande attenzione durante la sua vita. La sua narrativa, complessa e innovativa, fu spesso incompresa, poiché andava oltre i limiti della cultura cilena dell’epoca. Emar, pur aderendo all’avanguardia, mantenne una posizione autonoma, opponendosi alle convenzioni letterarie tradizionali e al nazionalismo letterario dominante.
Negli anni ’30, la letteratura cilena attraversò un periodo di intensi dibattiti tra le correnti avanguardiste e quelle orientate al realismo sociale, riflettendo i cambiamenti storici e politici del paese. Nel 1935, la pubblicazione dell’Antología de poesía chilena nueva mise in luce le tensioni tra i poeti d’avanguardia, in particolare Huidobro e De Rokha, mentre Neruda si concentrava su un’arte più umanizzata, legata ai problemi sociali.
Nel 1938, emersero vari gruppi letterari, tra cui il gruppo surrealista Mandrágora e l’Alianza de Intelectuales de Chile, con posizioni spesso contrastanti. Lo stesso anno segnò una svolta politica con l’elezione di Pedro Aguirre Cerda, che rappresentò un’apertura verso le istanze sociali e culturali della classe media. La guerra civile spagnola e l’avvicinarsi della Seconda Guerra Mondiale contribuirono a consolidare l’interesse per il realismo sociale, che si affermò come tendenza dominante con opere come Hombres oscuros di Nicomedes Guzmán.
Nonostante i tentativi dell’avanguardia di imporsi, figure come Mandrágora e Juan Emar furono marginalizzate, in parte per la loro fedeltà a principi radicali e non convenzionali. Emar, con la sua narrativa innovativa, venne associato alle correnti surrealiste e al pensiero di Miguel Serrano, ma il contesto fortemente politicizzato del 1938 penalizzò la sua opera, percepita come “ermetica” e “desumanizzata”. Sebbene ignorata all’epoca, la sua produzione rappresentò un punto di incontro tra il criollismo e la generazione del 1938, ponendo le basi per una futura evoluzione della narrativa cilena verso una maggiore autonomia artistica.
Emar, insieme a Manuel Rojas, viene oggi considerato un “ponte” tra tradizione e innovazione, ma la linea realista di Rojas si dimostrò più influente, mentre la ricerca di una nuova lingua letteraria intrapresa da Emar fu riconosciuta solo retrospettivamente come cruciale per la storia culturale cilena del XX secolo.
Juan Emar è stato definito criptico ed ermetico, non solo per le sue scelte stilistiche, ma anche per la sua adesione ai principi dell’ermetismo e dell’occultismo. Attraverso i suoi diari e le lettere, emerge la sua ricerca spirituale, iniziata già nel 1913 con lo studio di teosofia e religioni occulte. Emar si distinse nel panorama culturale del suo tempo, rifiutando le convenzioni letterarie e scegliendo una scrittura autonoma slegata dalle istituzioni e dai poteri dominanti, orientata a un universalismo che superava i confini nazionalisti e di classe.
La sua esclusione volontaria dal panorama letterario cileno dopo il 1937, legata alla scarsa ricezione della sua opera e al desiderio di concentrarsi sul suo progetto Umbral ha contribuito a una temporanea “amnesia storica” della sua figura. Tuttavia, negli ultimi anni della sua vita (1955-1963), dedicati a scrivere, leggere e riflettere in isolamento, Emar ha lasciato un’eredità che oggi viene rivalutata. Nonostante la sua opera rimanga poco diffusa nei circuiti ufficiali, è letta da un pubblico più ampio e diversificato, segno di una crescente canonizzazione culturale.
Emar, consapevole del carattere innovativo e futuro della sua produzione, scriveva per lettori a suo tempo non ancora pronti. La sua influenza e il suo contributo al modernismo cileno sono stati fondamentali nel creare un’arte autonoma aperta alle discipline umanistiche e scientifiche, con una profonda connessione alla spiritualità.
Il protagonista di Ieri (pubblicato da Safarà Editore con traduzione di Bruno Arpaia) incarna le caratteristiche tipiche dell’artista d’avanguardia: una continua sperimentazione di sé e della realtà, un approccio anti-eroico, la ricerca del senso attraverso esperienze quotidiane, e un rifiuto delle norme borghesi di successo o fallimento. Questo soggetto vive la modernità con malinconia, angoscia e uno spirito di esplorazione urbana e interiore, trasformando il tedio in vitalità.
La trama è volutamente frammentaria e surreale, riflettendo il desiderio dell’autore di rompere con le convenzioni narrative tradizionali. Il romanzo si sviluppa attorno al racconto di un singolo giorno della vita del narratore, un uomo che vive esperienze apparentemente ordinarie ma ricche di elementi bizzarri e grotteschi.
Il narratore inizia la sua giornata visitando un’esibizione artistica stravagante, in cui un pittore tenta di catturare il concetto di infinito attraverso tecniche assurde. Prosegue poi in un ristorante, dove ordina un pasto in compagnia della moglie, ma l’esperienza si trasforma in un evento surreale, con dettagli improbabili e un senso di alienazione. Successivamente, la coppia assiste a un’esecuzione pubblica che si rivela una metafora macabra della società e dei suoi riti crudeli.
La giornata del protagonista si conclude con una serie di riflessioni filosofiche e contemplazioni sul significato dell’esistenza, sul tempo e sull’identità, che sfidano ogni linearità narrativa. Il titolo stesso, Ieri, suggerisce una relazione ambigua con il tempo, poiché gli eventi descritti sembrano sospesi in un’atemporalità irreale.
Ieri descrive un viaggio iniziatico attraverso una città fittizia ma realistica, dove i protagonisti, Juan e sua moglie Isabel, intraprendono un percorso che li porta a una rivelazione, superando le esperienze narrate. La città è sia uno spazio esterno sia una proiezione delle loro coscienze, e la narrazione riflette un’interpretazione sovversiva della narrativa tradizionale, con personaggi che esplorano il desiderio attraverso il viaggio, la memoria, la narrazione e il caso.
I protagonisti incarnano l’idea di transeunti: osservatori che attraversano spazi senza mai fermarsi, mossi da un’insaziabile ricerca. La struttura episodica del romanzo evita una progressione lineare, con ogni capitolo che culmina in un momento chiave spesso mediato da tre elementi o personaggi, seguendo un ricorrente simbolismo numerico.
Infine, la narrativa esplora la tensione tra libertà e destino, con l’idea che la ricerca, guidata da un’apparente casualità, si trasformi in necessità, ovvero in destino. Il soggetto avanguardista rifiuta la pianificazione borghese, vivendo in modo erratico e lasciandosi guidare dall’imprevedibilità degli eventi.
Attraverso il suo stile ironico, denso di digressioni e dettagli apparentemente insignificanti, Emar invita il lettore a mettere in discussione la percezione del tempo, della memoria e della quotidianità.
Ieri è un’opera innovativa che combina umorismo, critica sociale e sperimentazione linguistica, anticipando tendenze letterarie che emergeranno decenni dopo.
Ivana Casella