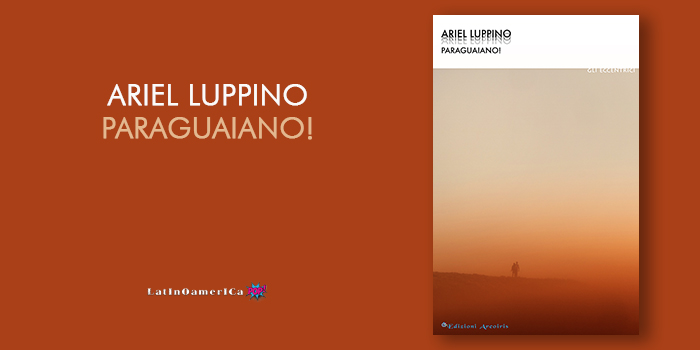Raúl Zecca Castel (Milano, 1985) è antropologo, documentarista e traduttore. Esperto di America Latina, ha collaborato alla realizzazione di vari documentari socio-antropologici per la RAI (Radiotelevisione Italiana) e la RSI (Radiotelevisione Svizzera Italiana). Ha pubblicato Come schiavi in libertà (Edizioni Arcoiris, 2015) e Mujeres. Frammenti di vita dal cuore dei Caraibi (Edizioni Arcoiris, 2020); nel 2022, traduce Chapeo (Edizioni Arcoiris, 2022) di Johan Mijail.
È lunga circa quattrocento chilometri quella linea di confine che si snoda, per dirla con le parole di Conrad, come un immenso rettile che affonda testa e coda nel Mar dei Caraibi, e avvelena le speranze di quei migranti haitiani che, una volta raggiunta la Repubblica Dominicana, vengono condotti nell’entroterra, dove verranno sfruttati come bracciantato agricolo nelle piantagioni di canna da zucchero e confinati nei bateyes, agglomerati di baracche che prendono il nome da un termine di origine taína riferito “al luogo dove gli indigeni giocavano” come spiega l’avvocatessa Méndez, ma che al giorno d’oggi indica quelle comunità di eredità coloniale inizialmente pensate come misure di contenimento di questi lavoratori, per lo più uomini e in maggioranza irregolari, dunque costretti a non abbandonarne il perimetro, per non rischiare di essere presi dalla polizia e deportati in un paese dove non gli è rimasto più nulla.
 È in questa realtà che, nel 2013, arriva per la prima volta l’antropologo italiano Raúl Zecca Castel; da qui nasce Come schiavi in libertà, la sua prima etnografia, pubblicata nel 2015 dalla casa editrice salernitana Edizioni Arcoiris e che ha il merito non solo di fare luce sulle condizioni di sfruttamento sofferte da queste persone, ma anche di smontare quell’immaginario idilliaco occidentale, per cui l’isola di Hispaniola è un suolo insulare in cui convivono serenamente due stati differenti per lingua e per cultura, Haiti e la Repubblica Dominicana, sostituendolo con la realtà che si traduce in una storia di immigrazione e di attese che si infrangono con la stessa facilità con cui i machete (che i tagliatori pagano di tasca propria) spezzano le canne da zucchero.
È in questa realtà che, nel 2013, arriva per la prima volta l’antropologo italiano Raúl Zecca Castel; da qui nasce Come schiavi in libertà, la sua prima etnografia, pubblicata nel 2015 dalla casa editrice salernitana Edizioni Arcoiris e che ha il merito non solo di fare luce sulle condizioni di sfruttamento sofferte da queste persone, ma anche di smontare quell’immaginario idilliaco occidentale, per cui l’isola di Hispaniola è un suolo insulare in cui convivono serenamente due stati differenti per lingua e per cultura, Haiti e la Repubblica Dominicana, sostituendolo con la realtà che si traduce in una storia di immigrazione e di attese che si infrangono con la stessa facilità con cui i machete (che i tagliatori pagano di tasca propria) spezzano le canne da zucchero.
Alla domanda su come sia entrato in contatto con questo contesto e cosa lo abbia effettivamente portato ad approfondire il tema, fa riferimento a un documentario girato nel 2007 da suo padre, il documentarista Adriano Zecca, dedicato ai migranti haitiani impiegati come bracciantato agricolo nelle piantagioni (Inferno di zucchero) e in cui raccolse la testimonianza di Christopher Hartley, missionario anglo-spagnolo, al tempo parroco della diocesi di San José de Los Llanos e impegnato in una crociata a difesa dei diritti dei braceros, pertanto inviso alla famiglia Vicini, proprietaria di un grande latifondo, dove tuttora si verificano condizioni di lavoro che noi a stento riusciamo a immaginare e nella cui persona si può individuare il vero filo conduttore tra il documentario e la ricerca portata avanti dall’antropologo che, inizialmente aveva una finalità completamente diversa, ossia quella di indagare le concezioni di corpo, malattia e cura elaborate da questi migranti e sugli effetti – in una prospettiva sociale della salute – e i “significati che determinate forze di ordine economico e politico producono sulla rappresentazione soggettiva della malattia e […] dell’esperienza quotidiana della sofferenza”.
Una realtà che lo ha condotto altrove
«Una volta arrivato lì mi sono reso conto del fatto che la mia intenzione fosse irrealizzabile, per il semplice fatto che questioni come la salute e la malattia passavano in secondo piano nel momento in cui il tema principale era la sopravvivenza, di per sé legata al lavoro, più precisamente alla possibilità di lavorare, nonostante lo sfruttamento, dunque la mia attenzione si è andata a concentrare sulle condizioni di lavoro, inteso in questo caso come strumento d’assoggettamento, da parte delle imprese verso i lavoratori, per estensione a tutte quelle dinamiche che creano una relazione verticale e di dipendenza, per la sopravvivenza […]. C’era questo pregresso del documentario di mio padre, in particolare il filo conduttore era questo missionario anglo-spagnolo (Christopher Hartley) che ho ricontattato, per un’intervista da inserire nella mia tesi, ma che non ho potuto incontrare in Repubblica Dominicana nonostante lui avesse operato per quasi dieci anni lì, poiché dopo quel documentario fu espulso dal paese, ma proprio in quell’anno (il 2013) aveva sottoposto al dipartimento del lavoro degli Stati Uniti una richiesta d’ispezione nelle piantagioni di canna da zucchero, in virtù del contratto bilaterale Cafta-Dr tra i due paesi, con l’ipotesi che le condizioni di lavoro violassero quanto stabilito da esso. Dopo aver aperto questa questione, sono iniziate diverse pressioni da parte delle imprese, sul governo che hanno portato alla rimozione del sacerdote dal suo incarico. Il caso vuole che mentre mi trovavo lì, venne inviata una delegazione sollecitata da Hartley, per una prima ispezione: li ho accompagnati nel batey, organizzando incontri con alcuni lavoratori che hanno condiviso la loro esperienza, nonostante le varie reticenze che da quella confessione sarebbero potute derivare e da lì è uscito un primo report che restituiva le criticità di quella situazione sofferta da queste persone, disponendo che venissero applicate migliorie, rispetto alle condizioni di lavoro dei braccianti. Ne sono stati pubblicati sei, sempre più approssimativi, in quanto furono un lavoro di concerto che è andato ad ascoltare governo e imprese, a scapito della voce dei lavoratori. Ogni volta che sono tornato, ho avuto modo di produrre materiale documentario, non solamente audiovisivo, quanto più interviste, testimonianze e in accordo con Hartley, lo abbiamo raccolto, per inviarlo al dipartimento del lavoro. Un piccolo, ma significativo passo in avanti si è compiuto non molto fa, con la decisione del governo statunitense di proibire le importazioni di zucchero dalla Repubblica Dominicana, precisamente dalla Central Romana, la maggior produttrice, nel caso in cui non vengano rispettati e tutelati i diritti dei braccianti coinvolti nella produzione: questo sicuramente è un successo, per questo processo che va avanti da dieci anni e sembra essersi incamminato verso la giusta direzione, per quanto resta da vedere quali saranno – a lungo termine – i suoi risvolti».
C.P.: Rispetto a questa decisione politica presa dagli Stati Uniti, apriamo una piccola parentesi sul libro che recentemente hai tradotto, Chapeo, in cui Johan Mijail, in riferimento al Vicino del Nord e alla sua politica imperialista e in modo evocativo, poetico e tagliente parla della violenza di un cieco interventismo, quanto della promessa di un passaporto con visto che ha ammaliato molti suoi connazionali. Per quanto gli Stati Uniti abbiano adottato una misura tesa a contrastare questo meccanismo di sfruttamento, anch’essi hanno in qualche modo contribuito al suo consolidarsi, dunque, brevemente, qual è stato il loro ruolo; ancora e qual è la percezione che il popolo dominicano ha rispetto all’immaginario formatosi attorno all’ex potenza, che pensandoci ha trovato anche una sua narrazione in letteratura?
R.Z.C.: Gli Stati Uniti hanno da sempre ricoperto un ruolo importante, nel panorama geopolitico, anche rispetto all’America Latina, il cosiddetto giardino di casa. Nel caso dei Caraibi a maggior ragione, poiché questi ultimi hanno rappresentato un punto nevralgico nel panorama geopolitico internazionale, sicuramente soprattutto rispetto alla questione zucchero, che per quanto sia un prodotto che attualmente ricopre un ruolo, se vogliamo, marginale, ha rappresentato per anni una fonte economica importante e di cui i Caraibi sono stati per decenni i maggiori produttori e che hanno dato il via, secondo alcuni, alla possibilità per le fabbriche europee di prosperare, adottando ritmi sempre maggiori, grazie allo zucchero utilizzato come riserva energetica per gli operai, dunque ecco che i Caraibi sono stati spesso letti come il motore del sistema capitalista mondiale: questo non poteva sfuggire agli Stati Uniti, il cui intervento aveva anche lo scopo di arginare la possibilità che questi stati seguissero il modello politico adottato da Cuba, eventualità che avrebbe messo in discussione il sistema politico dominante; quest’ultima cosa trova un precedente, ad esempio, nella questione haitiana. Haiti è diventata un immaginario pericoloso, data la rivoluzione condotta contro la madrepatria, protagonista di quella che è stata forse la madre delle rivoluzioni europee e i cui ideali animarono il movimento che si innalzò nell’attuale stato dell’isola di Hispaniola e che vennero immediatamente percepiti come un pericolo. Da qui, l’ex colonia francese si è ritrovata in una situazione di isolamento, con un ingente debito da saldare che ha generato una grande povertà, con cui i suoi cittadini si trovano tutt’oggi a fare i conti. Il ruolo degli Stati Uniti, proprio come simbolo dell’imperialismo è stato e continua ad essere determinante nei Sud del mondo, in generale e rispetto alle parole di Johan, questo termine cessa di avere un’accezione solamente militare, quanto più arriva a coinvolgere gli immaginari attraverso cui si trasformano e determinano speranze, desideri e sogni di persone che man mano incorporano determinati modelli e ideali di essere: così gli USA diventano meta e luogo utopico da raggiungere, che permette la fuga da un contesto, in questo caso la Repubblica Dominicana, con la promessa che si attualizzino quelle aspettative di benessere.
Luoghi, tempi e persone
 In Repubblica Dominicana, dopo il collasso dell’industria saccarifera a cui è seguita una grave crisi, il governo ha scelto di cedere la gestione degli zuccherifici statali ai privati, famiglie disponenti di grandi capitali, mosse dall’obiettivo di trarre dalla produzione il massimo profitto possibile, anche a scapito delle condizioni dei lavoratori, costretti a turni di dieci ore al giorno per uno stipendio che gli consente a malapena di sopravvivere alla giornata e che non potrà mai essere sufficiente a garantirgli alcuna prospettiva di riscatto, che hanno visto sempre di più sfumare quando, nel 2013, l’abrogazione della legge di acquisizione della cittadinanza per Ius Soli, con valore retroattivo, ha causato un consistente apolidia, che ha spogliato queste persone dei loro diritti civili, esponendole al rischio della deportazione. Queste circostanze che hanno contribuito ad intrappolare gli abitanti di queste comunità in un circolo vizioso e hanno reso questi agglomerati di baracche dei piccoli microcosmi, che rappresentano da un lato una protezione, poiché la polizia non vi entra, ma anche una prigione, che ha confinato questa gente in un silenzio assordante, che rende difficile entrare in confidenza con gli abitanti dei bateyes, dunque scoprire le loro storie soffocate da distese verdi interminabili, assediate dalla luce di un sole eterno.
In Repubblica Dominicana, dopo il collasso dell’industria saccarifera a cui è seguita una grave crisi, il governo ha scelto di cedere la gestione degli zuccherifici statali ai privati, famiglie disponenti di grandi capitali, mosse dall’obiettivo di trarre dalla produzione il massimo profitto possibile, anche a scapito delle condizioni dei lavoratori, costretti a turni di dieci ore al giorno per uno stipendio che gli consente a malapena di sopravvivere alla giornata e che non potrà mai essere sufficiente a garantirgli alcuna prospettiva di riscatto, che hanno visto sempre di più sfumare quando, nel 2013, l’abrogazione della legge di acquisizione della cittadinanza per Ius Soli, con valore retroattivo, ha causato un consistente apolidia, che ha spogliato queste persone dei loro diritti civili, esponendole al rischio della deportazione. Queste circostanze che hanno contribuito ad intrappolare gli abitanti di queste comunità in un circolo vizioso e hanno reso questi agglomerati di baracche dei piccoli microcosmi, che rappresentano da un lato una protezione, poiché la polizia non vi entra, ma anche una prigione, che ha confinato questa gente in un silenzio assordante, che rende difficile entrare in confidenza con gli abitanti dei bateyes, dunque scoprire le loro storie soffocate da distese verdi interminabili, assediate dalla luce di un sole eterno.
C.P.: Com’è avvenuto l’incontro tra te e gli abitanti delle comunità che hai visitato, e qual è stato il processo affinché ti guadagnassi la loro fiducia?
R.Z.C.: Ci sono due aneddoti che vale la pena raccontare e che aiutano anche a sintetizzare quelle che sono le difficoltà, sicuramente, ma anche quelli che sono i privilegi dell’essere antropologo: innanzitutto, l’avere molto tempo a disposizione è una grande fortuna, ma soprattutto un qualcosa di imprescindibile. Ci sono due aneddoti speculari che restituiscono questo discorso. Nel 2013, fu molto difficile parlare con i tagliatori, c’era molta diffidenza che imputavo al fatto di essere un uomo bianco e straniero. C’era una ritrosia generale, ma poi sono entrato in contatto con un mio coetaneo con cui sono riuscito ad entrare in confidenza. Fu lui a rivelarmi che, inizialmente, la prima volta in cui mi videro, pensarono fossi lì per una sorta di supervisione e con il fine di acquistare un terreno da destinare alla macinazione dello zucchero. Ciò mi aiutava a definire quale fosse l’immaginario che queste comunità avevano costruito attorno all’uomo bianco, associato per lo più all’immagine dello sfruttatore, con nessun altro fine se non quello di gestire affari relativi alla produzione e alla manodopera, intesa come oggetto mercificato.
«Quand’è che vieni ad ascoltare la mia di storia? Perché anch’io ho una storia da raccontarti».
Quelli che inizialmente erano dei villaggi informali, nati per ospitare i migranti haitiani per la stagione del raccolto, sono diventate delle vere e proprie comunità sociali, in cui vi sono delle famiglie che riversano in condizioni di estrema povertà. Nella premessa al suo secondo libro, che vede Raúl Zecca Castel ribaltare la sua prospettiva di ricerca, decidendo di indagare sulla componente femminile dei bateyes e spiega che, se mentre i braccianti sfruttati nelle piantagioni dalle imprese saccarifere sono sottoposti a condizioni di lavoro più volte definite in termini di schiavitù moderna, la situazione vissuta da donne e bambini è forse ancora più difficile. In quelle “carceri senza sbarre”, non hanno accesso a nessun servizio e a nessuna fonte di reddito: ciò le conduce a instaurare rapporti di convenienza con partner molto più grandi di loro, esponendole al rischio di violenze fisiche e psicologiche, o le costringe ad affidarsi all’unica cosa che gli appartiene davvero: il loro corpo. Nel 2020, viene dato alle stampe Mujeres. Frammenti di vita dal cuore dei Caraibi, il secondo libro dell’antropologo, frutto di un lavoro di ricerca condotto nel batey Ciguapa, comunità in cui l’autore, nel 2017, ha trascorso circa sei mesi, a stretto contatto con le donne, condividendo la loro quotidianità e ascoltando le loro storie. Dopo un accurato lavoro di selezione, sono sette le testimonianze riportate tra le pagine di Mujeres, che vede le protagoniste esprimersi su dieci aspetti della vita all’interno dei bateyes, emersi come significativi durante le conversazioni intrattenute con loro.
«Nel momento in cui la prospettiva di ricerca si è ribaltata, dunque quando ho deciso di indagare sulla sfera relazionale delle donne all’interno dei bateyes, invece il senso di diffidenza iniziale era mio, mi chiesi infatti quanto effettivamente potessi avere accesso a quel tipo di dimensione, in quanto uomo, pensando che non avrebbero trovato alcuna giustificazione per condividere le loro esperienze con me. Dunque sono stato molto attento, nel chiedere appuntamenti, nel presentarmi con il registratore. A volte mi è capitato che, una volta spento quel registratore, iniziassero ad aprirsi e a condividere informazioni che, di fronte a quegli strumenti, si sentivano in difficoltà ad esternare. Per cui, da un punto di vista metodologico, ho deciso di ripensare quel setting, per non porre alcun filtro tra me e loro, dunque abbandonarmi al vivere quotidiano, nel senso di condividere grandi camminate, momenti di relax, stimolare una situazione piuttosto che un’altra o molto spesso esponendo quella che era la mia dimensione più personale, quindi dare io per primo, invece che pretendere qualcosa. Aldilà di una strategia che c’è dal punto di vista antropologico, subentrano delle relazioni talvolta amicali, di dialogo: un esempio, due di queste donne sono arrivate al punto di raccontarmi cose che mai avrei osato chiedere. Tuttavia, la vera svolta è stata, quando mentre camminavo nella comunità, mi si avvicinò una donna che quasi rimproverandomi, mi chiese: «Quand’è che vieni ad ascoltare la mia di storia? Perché anch’io ho una storia da raccontarti». Da lì ho capito che ciò che stavo facendo fosse importante anche per loro e che non stessi semplicemente raccogliendo del materiale: era diventato qualcosa di condiviso, non solo la mia esigenza dell’ascolto, ma anche la loro di raccontarsi, infatti, a volte erano loro a cercarmi, per aggiungere dettagli o semplicemente raccontarmi la loro giornata. Mi rimasero impresse le parole della suora cubana che si trovava lì in quel momento, quando mi disse che, probabilmente, la ragione di questa apertura nei miei confronti, della necessità di condividere la loro storia derivasse del fatto che prima di allora non ci fosse stato nessuno che avesse mostrato interesse per le loro storie, piuttosto che per i loro corpi».
C.P.: Nella prefazione di Mujeres. Frammenti di vita dal cuore dei Caraibi vi è una frase molto significativa: “Non ci sono né eroine, né vittime, nessuno da acclamare, nessuno da salvare”. Leggere queste parole, di fronte alla consapevolezza delle difficoltà sofferte da queste donne, ognuna con esperienze di vita così distanti da quelle da cui uno sguardo a quel contesto esterno proviene, inevitabilmente porta ad interrogarsi su quale sia stato il processo che ha coinvolto te personalmente, affinché il tuo punto di vista si spogliasse di qualunque preconcetto, per accogliere nella maniera migliore possibile le storie di queste donne e infine restituirle in tutta la loro autenticità nel libro?
R.Z.C.: Il libro stesso è stato un processo, che si è forse concluso nel momento in cui è stato tradotto in spagnolo (Bateyeras. Testimonios de vida del corazón del Caribe – ediciones Cielo Naranja) cosa che mi ha permesso di onorare quello che era l’obiettivo principale – per quanto mi riguarda – di questo lavoro, ossia trascrivere queste storie, per poi restituirle prima di tutto a loro. È chiaro, ognuno di noi ha delle lenti di osservazione del mondo e non saremo mai in grado di abbandonarle del tutto, così come abbiamo la tendenza a etichettare sulla base dell’esperienza. Tuttavia, interfacciarsi con un contesto così diverso, vedere come viene vissuta una determinata realtà quotidiana, di come se ne affrontano le criticità, ci aiuta a scorgere l’incompletezza di quelle etichette, contestualmente l’impossibilità di una di escludere totalmente l’altra: pensando alle donne con cui ho parlato e alla frase in questione, probabilmente, rispetto alle loro esperienze di vita, sono sia eroine che vittime, però sono anche tantissimo altro. Sono persone, ognuna con la sua storia, ognuna con il suo punto di vista e con le sue contraddizioni. Non avevo alcuna intenzione di usare le loro storie come mezzo per veicolare un’immagine della donna del terzo mondo: da ciò deriva la scelta di ricorrere, se vogliamo a un espediente letterario, quello dell’oralità biografica, dunque inserire le loro testimonianze al netto di qualunque mia modifica e limitare il mio intervento solamente alle introduzioni iniziali di ogni sezione, per far sì che quelle contraddizioni uscissero fuori, per restituire al lettore la loro complessità, solamente attraverso le loro parole».
C.P.: Arriviamo all’ultimo libro, Chapeo di Johan Mijail, un libro potente e visionario, tuttavia che si discosta da ciò di cui abbiamo parlato fino ad adesso, ma che, analizzando la tua ricerca, si rivela un passo ulteriore di un percorso coerente, che trova la sua sintesi in questa dicotomia: “parole” e “corpi”. Questi ultimi sono intrappolati in un sistema ostile, fatto di violenza, discriminazioni, diritti negati, ma le loro parole no – lo hai scritto tu –, risuonano forti e vive, cariche di significato, e in Chapeo diventano materia viva, ma inafferrabili, intraducibili, perché – riprendo quanto hai scritto nella prefazione al libro – “legittimamente proprie di chi le vive e le ha vissute sul proprio corpo”. Com’è nato il progetto della traduzione di Chapeo, quali sono state le maggiori difficoltà che hai riscontrato in questo lavoro e di quelle parole, come sei riuscito a restituirne il significato più profondo, che va ben oltre la ricerca di un loro eventuale corrispettivo? Rileggendola, cambieresti qualcosa?
R.Z.C.: Quello con Chapeo è stato un incontro che è avvenuto, si può dire, per caso. Fu lǝ stessǝ autorǝ a inviarmelo, dopo che mostrai il mio interesse nel leggerlo. Quando lo ricevetti, aprii il file con l’intenzione di dare solo un rapido sguardo iniziale al libro, ma la lettura riuscì a catturarmi talmente tanto che dopo due ore e senza accorgermene ero già arrivato alla fine. Da lì, la mia ferma volontà di dare inizio a quel progetto che avrebbe portato alla sua traduzione in italiano. È stato un lavoro molto complesso, in primis da un punto di vista linguistico: Johan Mijail scrive in spagnolo – sarebbe più corretto dire che scrive in dominicano – dunque ha inserito all’interno del testo dei termini molto marcati, per cui è difficile trovare una corrispondenza netta e precisa nella nostra lingua. Al contempo, non è stato un compito facile nemmeno e soprattutto dal punto di vista strutturale e concettuale. All’interno di Chapeo vi sono delle parole che denotano una grande sofferenza e si riuniscono in una narrazione che potremmo definire un vero e proprio flusso di coscienza che in alcuni casi è stato difficile da seguire e che mi ha condotto a prendermi molte responsabilità, dal punto di vista traduttivo. Tu hai detto che mi son presentato ai miei lettori in un’altra veste, ma effettivamente, col senno di poi, mi sento di dire che non sia stato proprio così, piuttosto, in qualche modo sento di averlo tradotto da antropologo, in alcuni casi violando i codici, cercando di restituire il significato: ciò mi ha reso molto preoccupato, al momento di inviare la prima bozza della traduzione a Johan, di cui rimase immediatamente contentǝ. Tuttavia, in questa esperienza il momento migliore è stato senz’altro quando ho inviato la prefazione che ho scritto per il libro, che ho letto e tradotto sul momento, in un audio WhatsApp e in risposta, mi disse che si era emozionatǝ. Poi è chiaro, rispetto al fatto se cambierei qualcosa o meno, si dice che si pubblica per smettere di scrivere.
Claudia Putzu